In primo Piano
Articoli pubblicati da Luigi Favino

Giusto processo e dignità delle persone
di Luigi Favino
PREFAZIONE DI TITTA MADIA JR. (DIRETTORE DELLA RIVISTA "GLI ORATORI DEL GIORNO"). Un Avvocato di vasta cultura "scopre" un argomento nuovo e sorprendente: Il Vangelo è cultura dei diritti fondamentali della persona umana, di quelli più moderni che riguardano i fanciulli, la donna, l'intangibilità della vita umana ed il giusto processo. In una colta conferenza tenuta per il Consiglio dell'ordine di Roma Luigi Favino illustra i passi del Vangelo che dimostrano il suo assunto...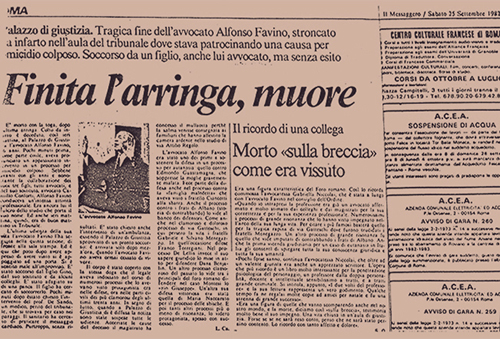
34° Anniversario morte avvocato Alfonso Favino
"Il Messaggero" Sabato, 25 Settembre 1982
ALFONSO FAVINO, MUORE CON LA TOGA DOPO ULTIMA ARRINGA. In occasione del 34° Anniversario, ricordiamo gli ultimi istanti della tragica morte dell’avvocato Alfonso Favino, sapiente penalista e scrittore, stroncato da infarto nell’Aula del Tribunale dove stava patrocinando una causa per omicidio colposo. Dal quotidiano romano de “Il Messaggero”, 25 settembre 1982: “E' morto con la toga, dopo l'ultima arringa. Colto da infarto è deceduto, così ieri mattina, al Palazzo di Giustizia l'avvocato Alfonso Favino.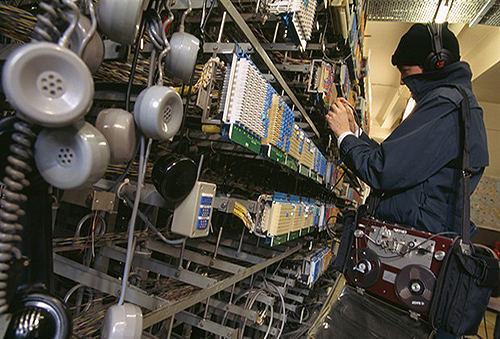
La sfera dei principi
di Luigi Favino
PUBBLICAZIONE DI INTERCETTAZIONI E VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI. Il concetto, come si sa, è una costruzione logica intesa a definire l'esistenza delle cose. Molti istituti giuridici derivano da concetti tradotti in norme di legge. Il diritto asseconda l'assolutezza connaturata alla figura del concetto poichè in relazione al valore considerato è in grado di modulare la propria produzione precettiva comprendendovi ogni profilo, il più e il meno, il nero e il bianco, il genere e la specie, sicchè si può dire che tra tutte le categorie dello spirito...
2007 - La spy story Ferrari-MacLaren. In meno di un anno chiuse le inchieste, accertata la verità, eseguita la sentenza
di Luigi Favino
IL FURTO DEI DOCUMENTI TELEMATICI E LE TRE ISTRUTTORE CONTRO LA MC LAREN. La nostra giustizia dovrà ispirarsi sempre più a quella internazionale per risolvere brillantemente ed in poco tempo le questioni giuridiche più complesse e delicate, senza inutili e defatiganti processi infiniti, dopo l'esito di questa spy story che ha appassionato il grande pubblico sui media...
L'Europa dei diritti dell'Uomo tra Convenzioni internazionali ed immunità degli Stati Sovrani
di Luigi Favino
PREFAZIONE DELL'AVV. LORENZO QUADRI DEL FORO DI ROMA. Il lavoro dell'avv. Luigi Favino analizza alcune interessanti convenzioni internazionali, tra le meno conosciute dal grosso pubblico in materia di deroga alla giurisdizione penale dei tribunali ordinari, come quella ad esempio che ha permesso ai militari americani di stanza in Italia di essere giudicati negli Stati Uniti per fatti relativi alla strage del Cermis di qualche anno fa.
Il paradosso e il mistero di un ricordo mondiale che dura immutato negli anni: quello di James Dean
di Luigi Favino
UN BINOMIO INSCINDIBILE TRA L'ATTORE E IL PILOTA. E’ ormai un mito tutto quello che attiene a questo giovane, mancato anzitempo a 24 anni, e che ha emotivamente coinvolto più di una generazione con soli tre film negli anni cinquanta, interpretati con straordinario ed innato talento. Anche quest'anno la sua leggenda ha avuto in regalo “Life”, un bellissimo film presentato al Festival di Berlino 2015...News
Articoli pubblicati da Luigi Favino

Disapplicazione delle sentenze di condanna agli stranieri clandestini ed "inefficacia" della direttiva europea sui rimpatri
di Luigi Favino
Sul reato di cui all'art. 14, comma quinto ter, del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 (legge Bossi- Fini) riguardante la violazione dell'ordine di rimpatrio impartito dal Questore, è intervenuta la Direttiva 2008/115 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, in data 16 dicembre 2008, che prevede norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio...
La tutela della privacy a tutti i costi, non può violare i diritti umani
di Luigi Favino
Sul piano ermeneutico, tanto processuale che sostanziale, il tema del consenso giuridico è sempre stato uno dei più spinosi e complessi. Non parliamo poi di quello a senso unico, quasi a tutti i costi, del consenso sui dati personali di cui alla Direttiva 95/46CE sulla privacy, che affronta numerosi argomenti tecnici, tra cui quello della videosorveglianza pubblica e privata, con una logica inflessibile tutta nordica.
La prevedibilità dell'incidente in un caso di guida imprudente della vittima e dell'investitore
di Luigi Favino
E' questo il tema di una recente sentenza della Cassazione della IV Sezione Penale, che ha annullato una precedente decisione della Corte d'Appello di Bari, disponendo un nuovo processo. In sintesi, si trattava di un omicidio colposo, conseguente ad un incidente stradale, in cui l'imputato, che viaggiava ad una velocità superiore a quella imposta, ha investito un veicolo che aveva effettuato un'improvvisa svolta a sinistra...
Tentato omicidio con auto altrui: proprietario non ne risponde
di Luigi Favino
In un caso recente di guida dell'auto altrui, conclusosi con delle lesioni gravi procurate ad un pedone la Cassazione 1a Sezione Penale - Pres. Fabbri - Rel. Chieffi - n. 22890) ha motivato che quando si fa un uso distorto dell'autovettura sicuramente non rientrante nel concetto di circolazione stradale adoperandosi il veicolo in modo non conforme alla sua destinazione naturale, ma come strumento di offesa per schiacciare una persona a causa della condotta...
Non basta vedere ma, contestare subito automobilista uso cellulare
di Luigi Favino
Parte della giurisprudenza del Giudice di Pace di Roma annulla la contestazione contravvenzionale dei VV.UU. tutte le volte che si sottrae all'obbligo della immediata contestazione. Rivive così l'esercizio del diritto di difesa dell'automobilista sancito dall'art. 23 penultimo comma della L. 689/1981 sulla depenalizzazione anche nel caso frequente dell'uso di un cellulare in auto privo di auricolare e di sistema a viva voce in violazione dell'art. 178, co. 2, C.d.S...
I ricorsi al Giudice di pace per le multe stradali
di Luigi Favino
L'OBBLIGO DELLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DEL VERBALE DI VIOLAZIONE E SUA IMPORTANZA NEL SISTEMA DELLA PATENTE A PUNTI ALL' INDOMANI DELLA DIRETTIVA MARONI 21 AGOSTO 2009. La contestazione immediata della violazione ai sensi dell'art.201 C.d.S. è un obbligo posto dal Legislatore a carico degli agenti incaricati del controllo e del pattugliamento delle strade che non conosce deroghe, se non in alcuni casi specifici elencati nel comma 1 bis della stessa norma...Blog
Articoli pubblicati da Luigi Favino

Sant'Alfonso protettore di avvocati e giuristi
di Luigi Favino
PROFESSIONE FORENSE: "DICHIARAZIONE SU REGOLE MORALI AVVOCATO". Oltre che dei confessori, Sant’Alfonso fu proclamato protettore di avvocati e giuristi già dal 1871, quando era già stato canonizzato e nominato Dottore della Chiesa. Era nato a Marinella, in provincia di Napoli, nel 1696, in una nobile famiglia che lo avviò, dopo gli studi classici, a quelli giuridici di diritto civile ed ecclesiastico, divenendo avvocato giovanissimo. Le cronache a questo riguardo, narrano che avesse appena 18 anni...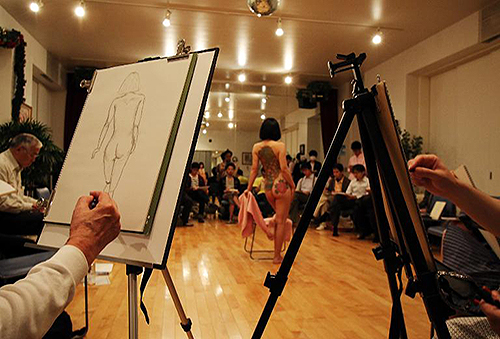
La pretesa disumanizzazione del modello nell'opera d'arte
di Luigi Favino
IL CONSENSO DEL MODELLO DELLA RIPRODUZIONE DELL'OPERA D'ARTE. Nella delicata e complessa materia della disponibilità dell’opera e delle facoltà spettanti ai singoli partecipi vige un principio che può senz’altro considerarsi scontato: la posizione non può essere riguardata da un angolo visuale unilaterale dei rapporti ma considerata invece sulla base di un equilibrato contemperamento della posizione di tutti i soggetti interessati; principio questo che si inquadra nella disciplina generale della materia de qua.
ALLA PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA LE BELLE AUTO DELL'ASI AUTOSHOW
di Luigi Favino
L’ultima settimana di settembre 2018 ha visto bellissime auto storiche e d’epoca rivivere nei viali che costeggiano le Terme di Caracalla il fulgido passato delle “vecchie signore”. La Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca si è conclusa a Roma domenica 23 settembre con un Convegno al Senato e con centinaia di vetture giunte da tutta la Penisola a mostrare ancora una volta il genio dello stile italiano al grosso pubblico della Città Eterna. Ferrari e Maserati, a decine erano parcheggiate al sole di Roma...GIOACCHINO BELLI IL PIU' GRANDE POETA ROMANESCO DI TUTTI I TEMPI
di Luigi FavinoAvvocato del Foro di Roma e giornalista pubblicista

ROMA CAPITALE AL TEMPO DEL BELLI
Difficile immaginare la grandezza di Roma capitale dello Stato Pontificio ottocentesco, senza la lettura dei Sonetti di Giuseppe Gioachino Belli. Di quella Roma, Gioachino è stato l’intelligente narratore “inventandosi”, come si dice oggi, un’opera gigantesca; come Orazio che diceva dei suoi versi “Exegi monumentum aere perennius”[1], altrettanto egli scriveva che il suo “Commedione” doveva intendersi come un monumento alla plebe romana, della quale metteva in luce spirito, costumi e modi...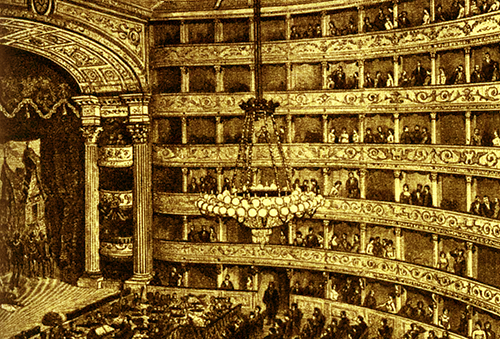
LA GAIA SOCIETA’ DEL BELLI TRA TEATRI E SALOTTI DELLA CAPITALE
Nella Roma di metà Ottocento ferveva una vita molto intensa fatta di eventi musicali, teatrali ed artistici. A questi, il popolo descritto dal Belli nei Sonetti, partecipava attivamente affollando soprattutto spettacoli di ballerine e il nuovo genere "composito" di quegli anni: il melodramma, un po' tra il "musical" americano dei nostri anni Venti con balli, prosa, romanze o assoli, ma tuttavia simile all'operetta". La quale senza essere la figlia minore dell'opera lirica, pur tuttavia ne costituiva un superamento...
IMPRESSIONI DI POETI E SCRITTORI "TURISTI" NELLA ROMA DEL BELLI
“La cupola I'ho veduta io con la mia corta vista a cinque miglia di distanza mentre io sempre ero in viaggio; e I'ho veduta distintamente con la sua palla e colla sua croce come voi vedete di costà gli Appennini". Così scriveva Giacomo Leopardi alla sorella Paolina il 3 dicembre 1822, quando venuto a Roma da Recanati aveva intravisto la Capitale percorrendo la via Flaminia; quasi una sorpresa questa visione ma assieme a tante altre impressioni non tutte positive, tra cui quella che Roma fosse...Info
Articoli pubblicati da Luigi Favino

INFORMAZIONI GENERALI
di Luigi Favino
Il sito web "www.luigifavino.it" non costituisce testata giornalistica e la diffusione di eventuale materiale interno al sito non ha comunque carattere periodico ed è condizionata alla disponibilità del materiale stesso. I testi, le informazioni e gli altri dati pubblicati in questo sito nonché eventuali link presenti sul web hanno esclusivamente scopo informativo e non assumono alcun carattere di ufficialità. Pertanto Luigi Favino non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni di qualsiasi tipo...
INFORMATIVA PRIVACY
di Luigi Favino
Nella presente sezione viene fornita l'informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito di LUIGIFAVINO.it, ha valore anche ai fini dell' art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali. LUIGIFAVINO.it rende noto che il trattamento dei dati personali sarà conforme a quanto previsto dalla normativa vigente. L’ informativa è resa in ordine al trattamento...
INFORMATIVA UTILIZZO DEI COOKIE
di Luigi Favino
Nella presente sezione viene fornita l'informativa per l'utilizzo dei cookie. I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, memorizzazione...Contatti
Articoli pubblicati da Luigi Favino
Giusto processo e dignità delle persone
di Luigi Favino
PREFAZIONE: TITTA MADIA JR. (DIRETTORE DELLA RIVISTA "GLI ORATORI DEL GIORNO"). Un Avvocato di vasta cultura "scopre" un argomento nuovo e sorprendente: Il Vangelo è cultura dei diritti fondamentali della persona umana, di quelli più moderni che riguardano i fanciulli, la donna, l'intangibilità della vita umana ed il giusto processo. In una colta conferenza tenuta per il Consiglio dell'ordine di Roma Luigi Favino illustra i passi del Vangelo che dimostrano il suo assunto e che richiamano le Fonti più alte del diritto nazionale ed internazionale. Con una finale perplessità: "Quel povero Cristo, destinatario principale di quei diritti, ha diritto a ben poco...".
(Testo dell'intervento dell'autore alla conferenza organizzata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma il 14/12/10 dal titolo "I diritti fondamentali dell'uomo dalla antica Roma all'avvento del Cristianesimo", di cui sono stati anche relatori l'Avv. Domenico Giustiniani, il Prof. Gian Luigi Falchi, con il coordinamento dell'Avv. Giovanni Cipollone. Pubblicata dalla nota rivista "Gli Oratori del Giorno" (n. 6/2011) diretta dall'avv. Titta Madia.)
PREMESSA SUI DIRITTI UMANI E LE PARI DIGNITA' DI OGNI PERSONA, COMPRESI I FANCIULLI. Quando l'evangelista Matteo ci racconta i due miracoli della moltiplicazione dei pani, per meglio illustrare il grande numero di persone che fruirono di quell'improvvisata colazione "en plein air" fa notare che avevano mangiato migliaia di uomini… "senza contare le donne e i bambini". Sicuramente altre bocche da sfamare, ma che se anche fossero state tante, anche il doppio degli uomini, non sarebbero entrate a far parte di una statistica ufficiale, proprio perché non contavano nulla in quel tempo in cui Gesù si manifestava nella vita pubblica, dopo trenta anni di vita nascosta a Nazareth. Donne e bambini non erano considerati persone, soggetti di diritti, non solo in Palestina ma in tutto il mondo di allora. E' proprio qui che comincia la "rivoluzione annunciata da Gesù e riassunta da ben quattro discepoli, nei Vangeli, che ripercorrendo il percorso biblico del disegno della salvezza universale, tracciano un vivo ritratto di Gesù, nella sua vita pubblica mentre operava cose mirabili e soprannaturali, comunicando l'amore di Dio verso tutti, donne e bambini compresi, perché per ognuno di loro c'era la salvezza, perchè erano i piccoli, le creature più fragili, i poveri, coloro che, per malattia o miseria, vivevano in una condizione di abbandono ai margini della società. Uno dei motivi che stavano alla base della situazione di inferiorità sociale e giuridica della donna a quel tempo, era sicuramente la condizione della stessa nella famiglia a causa del matrimonio e della legge mosaica, che ammetteva il ripudio da parte del marito sulla base di un semplice sospetto di infedeltà che, a volte come pretesto, metteva fuori gioco la donna ponendola ai margini della società. Per tutti costoro, nessuno escluso, persone a tutti gli effetti, perché dotate di anima, i Vangeli annunciavano con la conversione ed il battesimo, la "novità" della filiazione divina e della dignità della persona umana, fatta ad immagine di Dio, dell'uomo e della donna singolarmente, con parità, per ognuno, dei diritti fondamentali.
LA DONNA CRISTIANA NON PUO' ESSERE RIPUDIATA. Tuttavia avvenne che proprio a causa del Vangelo, la donna riacquistasse nuovamente la propria sicurezza nel nuovo matrimonio che non ammetteva più il ripudio, in quanto cristianamente unita con il marito, grazie al vincolo di indissolubilità concepito da Cristo per quel sacramento. "Fu proprio per la durezza del vostro cuore, che Mosé vi concesse di ripudiare la moglie" (v. il Vangelo di Marco 8,6); "perciò non è lecito all'uomo separare ciò che Dio ha unito perché all'inizio della creazione non era così". Era nato il matrimonio cristiano, basato
sull'amore degli sposi che sono i ministri del sacramento, che come tale rientra nel progetto infinito della creazione che si compie con la grazia degli sposi e l'azione dello Spirito Santo. Di qui all'emancipazione femminile ce ne voleva ancora, se Edith Stein ha potuto scrivere che fino alla fine del mille e ottocento le donne erano equiparate giuridicamente e politicamente ai minorenni, ai fanciulli, ed ai minorati psichici. Categorie queste, soprattutto i bambini, che Gesù prediligeva, per cui i Vangeli molto spesso si diffondono su di essi, perché troppo spesso trascurati e disprezzati; Gesù, infatti, era intervenuto proprio per rivalutarli, ponendoli al disopra di tutti, esortando a diventare come loro "perché i bambini sono i più grandi nel regno dei cieli", o guarendoli e addirittura resuscitandoli, come nei miracoli della figlia di Giairo, e del figlio del capo della sinagoga: una rivoluzione copernicana questa, che vedeva la rivalutazione dei fanciulli considerati poco più di un oggetto, come del resto tutti i minori ed i piccoli, quasi fossero mezzi uomini o una vaga speranza di divenirli. La graduale emancipazione femminile: dal ripudio del marito al matrimonio Cristiano - Maria di Nazareth avvocato per i diritti di tutti Ma ritornando alla donna, i Vangeli stessi pongono in prima fila alcune figure femminili che attuarono cose eccezionali per l'epoca in cui vissero nel campo delle libertà individuali. Ad una di loro, alla Maddalena, e non a caso, Gesù affidò il compito di annunciare la cosa più grande che era accaduta quel giorno: la sua resurrezione dai morti, implicitamente nominandola apostolo per la conversione di molti, ben oltre la cerchia dei suoi familiari. Un incarico questo che anticipava il diritto alla libertà femminile ed all'autonomia della "persona donna", ritenuta da Papa Wojtila "un genio unico ed irripetibile". L'altra figura femminile ancora più grande fu Maria di Nazareth, destinata ad essere immacolata fin dalla nascita, per un disegno originario della salvezza universale e che volontariamente accettò su di se, con la nascita di Gesù, il mistero dell'incarnazione. Anche di lei si sono occupati i Vangeli, sia pure riservandole una parte marginale, ma che comunque ne faceva intravedere la presenza discreta e silenziosa, quale quella di una madre accanto al figlio adulto, ma che non le impediva di seguirlo insieme ai discepoli in mezzo alle folle che lo osannavano, oppure aspettandolo tra la gente che si raccoglieva in un posto, insieme ad uno sparuto gruppetto di altre donne, che sopperivano in qualche modo alle necessità degli apostoli.
FIGURE DI DONNE NEL VANGELO. Come Giovanni Battista, storica figura del Vangelo, precorse l'avvento del regno di Dio annunciando il Messia in quell' angolo sperduto del mondo orientale, come colui che avrebbe favorito e promosso la tutela dei più deboli, che non avevano voce, così Maria altrettanto cooperò a diffondere il messaggio cristiano, come ci dice San Luca nel suo Vangelo, dapprima nella cerchia familiare dei parenti, assistendo la cugina Elisabetta in una città lontana da Nazareth, fino alla nascita del figlio, ed intervenendo poi alle nozze di Cana come protagonista e mediatrice del primo miracolo di Gesù. E sempre San Luca riporta integralmente il testo del documento più significativo che è il Magnificat, che Maria pronunciò in uno di quegli scorci di volontariato, che era una vita attiva spesa in favore di chi aveva bisogno, anche tra i suoi parenti e quotidianamente. Il Magnificat è un documento di grande rilevanza, una dichiarazione di portata universale, una sorta di proclamazione dei diritti dei poveri, dei vinti e degli umili, a fronte di doveri e di virtù private. In questo documento che ha pregi, anche poetici, Maria tratta in una mirabile sintesi temi come la Misericordia,
la Giustizia Sociale, soprattutto dell'adempimento di antiche promesse bibliche; una sintesi dettatale dallo Spirito del Signore che era in lei e che le fa dire: "Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente", e che, addirittura, le fa anticipare profeticamente il suo futuro connesso con quello di tutta l'umanità, quando dice: "d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata". Ciò che poi si è avverato concretamente. Un ruolo così grandioso, da protagonista, mai fu affidato ad una donna, che nella sua umiltà è stata prescelta a qualsiasi altra donna del passato oltre che del futuro, per portare a termine la storia della salvezza universale, divenendo dopo l'assunzione, regina dell'universo accanto a Cristo Re. Solo per questa intelligente intuizione e volontaria adesione al progetto di Dio, Maria è divenuta colei che tutela più di ogni altro i diritti umani, le aspettative che ogni persona che a lei si rivolge come suo avvocato, che si sente ferito nel proprio intimo e le si affida nella preghiera stabilendo un contatto immediato, più veloce di qualsiasi comunicazione mediatica, o connessione virtuale che sia.
MISERICORDI E GIIUSTIZIA GIUSTA. Maria invia e riceve messaggi usando le vie del cuore per tutti quelli che soffrono e si lamentano, perché si sentono traditi nelle proprie attese e sentimenti; per quelli che sono preoccupati e disorientati, per quelli che soffrono senza mostrarlo, per quelli che si sentono isolati - diceva San Vincenzo senza volerlo - mettendo a disposizione la sua sensibilità di madre che va incontro ai cuori spezzati, in innumerevoli Fatima, Lourdes, Medjugorie, ed altre che ancora non conosciamo. Il tema della misericordia toccato da Maria nel Magnificat ha avuto fortuna nei secoli e noi penalisti siamo ormai certi che, nel concetto stesso di misericordia, sia racchiuso quello di una giustizia più giusta. Da una giustizia primordiale senza compassione e
misericordia, il concetto di una giustizia più completa, apportata da avvenimenti mondiali quali la nascita e la resurrezione dalla morte di Cristo, anche se banalizzati dalla deriva commerciale del Natale e della Pasqua di quest'ultimo scorcio di anni, è rimbalzato nei secoli riuscendo a fare modificare non solo usi, norme, e codici, ma interi sistemi penalistici in Europa e nel mondo, con l'introduzione di istituti come quello della sospensione condizionale, della "probation" inglese, come quello della pena giusta, in quanto personalizzata a misura del reo grazie alle circostanze attenuanti oggettive e soggettive, ai sensi degli artt. 62 bis, 69, e 133 del codice penale, come tutti i benefici nella fase di esecuzione delle pene. Il concetto di misericordia che era in principio attribuito al solo Dio, in una impostazione di tutta la teologia e delle filosofie orientali, si sintetizza in Maria di Nazareth così: "di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono...".
ELIMINAZIONE DELLA PENA DI MORTE - MISERICORDIA E GIUSTIZIA. E' con Cristo tuttavia che quel concetto rimane allo stato vivo in coloro che l'hanno recepito e trasmesso agli altri, battezzati e non battezzati, diventando ognuno misericordioso, come è lo stesso Cristo delle beatitudini, che rappresentano il vero e più reale, perché intimo, ritratto del volto di Gesù. Quello che vide la donna adultera che gli scribi e i farisei gli avevano condotto davanti mentre stava nel tempio con i suoi discepoli, con il segreto intento di farla condannare e lapidare. Da quel volto e da quelle labbra uscì soltanto una frase dirompente, mentre col dito scriveva per terra "Quello di voi che è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei". Quelle parole fecero dissolvere come d'incanto il processo
improvvisato, fecero andare via gli accusatori ad uno ad uno, a cominciare dagli anziani, e la donna rimasta sola non fu condannata. Da Eva in poi la donna continua a rimanere in bilico, quasi su un crinale, tra l'essere l'eterna tentazione per l'uomo, ma essere anche la madre dei suoi figli; e questa singolare condizione, per Ratzinger, fa della donna una persona assolutamente eccezionale, indistrutta dal peccato originale, e nello stesso tempo antagonista della morte. Per secoli la parola di Gesù che si legge nei Vangeli, che non è più la legge dei comandamenti del vecchio testamento, ma quella dell'amore e della misericordia, è riuscita ad eliminare le inevitabili discrasie tra leggi punitive inumane, e l'opinabilità di accuse eclatanti, orientando la politica criminale per l'abrogazione di leggi superate, soltanto afflittive, non in grado di ottenere la rieducazione ed il reinserimento del condannato nel contesto sociale, e che favorivano l'errore giudiziario. Esemplare ed indicativa a questo riguardo la graduale archiviazione della pena di morte non soltanto in Europa, dove in Gran Bretagna grazie alla regina Elisabetta II, che come capo di Stato e della Chiesa Anglicana, si allineò alla normativa abolizionista degli altri Stati del vecchio continente, non fu più considerata la privazione della vita a seguito di una condanna, come un deterrente per la diminuzione dei più gravi reati. Non a caso fu una donna che riuscì, meglio di altri, a mettersi in sintonia con quella sensibilizzazione alla tutela dei diritti fondamentali anche attraverso la misericordia. La fonte originaria della graduale eliminazione della pena di morte da qualunque società era sempre da ricercarsi nei Vangeli, dove Gesù aveva sempre detto: "voglio che tutti abbiano la vita, e l'abbiano in abbondanza", non solo perché si opponeva alla cultura della morte e dell'isolamento, guarendo tutti quelli che glielo chiedevano con fiducia, da infermità mortali come la lebbra e l'ossessione diabolica, altri salvando dalla corruzione del sepolcro, perché la morte andava distrutta alla radice e perché come tale era negazione della vita, soprattutto di quella soprannaturale. Malgrado tutto questo, Gesù fu condannato a morte, ma anche la sua morte si tramutò in vita per gli altri. Anche se non sono passati che duemila anni e poco più dalla sua morte, l'errore giudiziario che concluse il processo a Gesù ha segnato un'era nel calendario con quel prima e dopo Cristo, ed ha portato il tema della misericordia ben oltre i conventi e le cattedrali, ma come premessa di saggezza scritta sui muri a commento di affreschi come: "Initium sapientiae Christus in cruce".
IL PROCESSO A GESU'. Scrittori come Papini, Diego Fabbri, Charles Peguy, e Francois Mauriac si sono occupati in loro lavori o scritti di quel singolare processo iniziato con il rito accusatorio e l'interrogatorio dell'indiziato, al termine del quale Pilato esprime il suo convincimento agli accusatori che lo pressavano, per ben due volte, che lui, Pilato, non trovava alcuna colpa in quell'uomo; un processo che finì con il capovolgersi dopo l'intervento rumoroso della folla che urlando: "A morte! Crocifiggilo", intimorì non poco il suo giudice naturale, che lo consegnò con le guardie a chi ne voleva la morte, per farne eseguire l'ingiusta sentenza di condanna. Ma la condanna a morte di un innocente come Gesù, e la crocifissione, posero all'umanità altri complessi problemi oltre a quello della pena di per sé ed a sé stante; le torture prima del processo e quelle dopo, connesse con la pena crudele che veniva irrogata, ed infine il tema dell'errore giudiziario, e dell'ingiusta sentenza connessa alla pena capitale. Problemi tutti questi che continuano ad esistere nel mondo e, di quando in quando, si riaffacciano anche in quei Paesi dell'Europa che pensavano di averli debellati, perché le radici dell'odio spesso sono più profonde di quelle dell'amore e della misericordia. Sul piano dei diritti umani difficilmente una sentenza è giusta se si conclude con una condanna a morte, anche di un essere umano colpevole di atroci delitti (basti pensare alla recente condanna a morte per impiccagione di Saddam Hussein) ma i problemi relativi alla sovranità ed alla conseguente inviolabilità di ogni Stato e Nazione, unitamente al divieto di ingerenza rendono difficoltosa l'azione di contrasto all'esecuzione delle condanne a morte in tutto il mondo. La lentezza e la tempistica delle relazioni internazionali, spesso complicate anche da interessi di natura geopolitica ed economica, rende inefficace la risposta della comunità internazionale di fronte alla quotidiana violazione dei diritti umani sotto ogni forma ed anche nella sua massima espressione negativa, e cioè la condanna a morte di un essere umano. Il problema viene spesso affrontato in modo generico e spersonalizzato, come se risultasse assolutamente indifferente alla giustizia internazionale, non organizzata gerarchicamente se non in modo puramente teorico e generico a livello di Fonti del diritto, con strumenti asettici e soprattutto inefficaci come le moratorie e le varie espressioni di deplorazione.
IL PROCESSO INGIUSTO E LA CONVENZIONE DEI DIRITTI UMANI. Ma d'altra parte una sentenza ingiusta non può essere pronunciata in un processo giusto e, in questa ottica, il problema dell'ingiusto processo va affrontato con la stessa fermezza e con la stessa chiave di lettura. Un principio giusto, e cioè il diritto, quando viene interpretato senza una visione più ampia delle cose, senza lo sguardo d'insieme, senza tenere conto, in sostanza, di quell'afflato che lo rende giusto e che risiede prima che nel diritto nel cuore di ogni uomo, rimane pur sempre un principio perfetto nella forma, ma inesistente ed insignificante nella sostanza, in grado di sostenere il peso del processo sì da renderlo un processo formalmente regolare, ma non in grado comunque di rendere il processo giusto. Partendo dai codici di rito e del diritto sostanziale, scorrendo i principi della Carta Costituzionale, andando oltre a scandagliare il testo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e della successiva Convenzione, non può non notarsi il dato di fatto che i principi di quel nucleo dei diritti fondamentali, i diritti umani, sono tutti enunciati in modo chiaro e pacifico. Il principio del contraddittorio sostanziale e non meramente formale, il diritto di vedere la propria causa esaminata da un Tribunale regolarmente costituito ed imparziale, il vaglio sul fondamento di ogni accusa in tempi ragionevoli, il diritto ad interrogare o a fare interrogare i testimoni a carico, sono tutti principi cogenti che, quando non sono rispettati, hanno l'effetto di inquinare il processo alla radice, rendendolo sommamente ingiusto, e facendolo regredire allo stato primordiale del diritto, perché non è breve ma destinato a durare anni.
ESEMPI ANTICHI DEL GIUSTO PROCESSO. Ma anche nell'epoca più antica del diritto, ed addirittura ai tempi della legge Mosaica in Israele, alcuni principi del giusto processo venivano applicati: quando fu celebrato il processo a Susanna intentatole da due vecchi che falsamente l'accusavano, e che furono smascherati da Daniele in uno storico interrogatorio dei due, messi a confronto con l'innocente accusata. La giusta sentenza di assoluzione della stessa e della condanna dei falsi testimoni fu possibile per l'immediata, quanto provvidenziale, disposizione di un contraddittorio sostanziale tra le parti. Anche ai tempi del processo a Gesù, che tutto sommato a parte la sentenza ingiusta venne giudicato rettamente, si realizzò pienamente il principio del contraddittorio, mettendolo subito a confronto con i suoi falsi accusatori, secondo le regole del processo romano di marca rigorosamente accusatoria, con il risultato che lo stesso Pilato, come accennato, si convinse dell' innocenza dell'incolpato. Così come è stato sempre giusto il processo di stile romano che nei secoli è stato sussunto nel sistema garantista della Common Law, così è giusto il sistema processuale americano, dove ogni processo si celebra in un tempo davvero ragionevole con l'audizione immediata dei testi davanti al difensore dell'imputato e all'imputato stesso che può subito far valere la sua innocenza controinterrogando i testi dell'accusa, senza dover aspettare tempi biblici per doverlo fare, appunto perché breve. Tanto sarebbe giusto il nostro processo se fossero attuati in toto i principi racchiusi come in uno scrigno nelle Fonti più alte del diritto nazionale e sovranazionale, e cioè la Costituzione della Repubblica, la Dichiarazione Universale, e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle sue libertà fondamentali, tutti documenti dotati di anima e respiro universale, che si delineano e si configurano all'indomani di due sanguinosi e terribili conflitti mondiali. Non cogliere l'essenza dei principi e dei diritti enunciati significa perdere il senso più profondo delle cose umane, di principi che si rivolgono direttamente a tutti gli uomini come si riscontra anche soltanto formalmente nell'incipit di ogni paragrafo "Ogni persona ha diritto… ad essere giudicato in tempo ragionevole”. Un passo avanti potrebbe essere costituito dalla nuova legge sul “processo breve” in itinere al Parlamento, perché applicando un regime di trattamento differenziato tra incensurati e recidivi, potrebbe contribuire validamente alla eliminazione di molti processi arretrati pendenti, che comunque si sarebbero estinti per prescrizione; al fine di consentire, in tal modo, di potere ripartire al più presto con il “vero processo breve”, quello del tempo ragionevole scandito dalla Convenzione. Ed ove invece fosse disatteso lo spirito della norma, ed il suo disposto non dovesse poi applicarsi, constateremmo purtroppo che quel soggetto di diritto, quel povero cristo destinatario principale di quei diritti, ha diritto a ben poco, e la parte migliore del discorso rimane ancora inascoltata.
NOTE: L'ARTICOLO E' STATO PUBBLICATO SOLO IN ITALIA, SI VALUTANO RICHIESTE DI PUBBLICAZIONE SU STAMPA ESTERA
34° Anniversario morte avvocato Alfonso Favino
"Il Messaggero" Sabato, 25 Settembre 1982
ALFONSO FAVINO, MUORE CON LA TOGA DOPO ULTIMA ARRINGA. In occasione del 34° Anniversario, ricordiamo gli ultimi istanti della tragica morte dell’avvocato Alfonso Favino, sapiente penalista e scrittore, stroncato da infarto nell’Aula del Tribunale dove stava patrocinando una causa per omicidio colposo.Dal quotidiano romano de “Il Messaggero”, 25 settembre 1982: “E' morto con la toga, dopo l'ultima arringa. Colto da infarto è deceduto, così ieri mattina, al Palazzo di Giustizia l'avvocato Alfonso Favino. Pochi minuti prima, come parte civile, aveva pronunciato un appassionato intervento in un processo per omicidio colposo. Sebbene avanti con gli anni e nonostante la collaborazione dei suoi tre figli, tutti avvocati, e del suo sostituto, avvocato Camillo Conforti, Alfonso Favino conduceva un'intensa attività professionale. Era ancora lui il fulcro dello studio che porta il suo nome. Ed anche ieri mattina, quindi, era di buon mattino in Tribunale. L'ultima udienza della sua vita l'avvocato Favino l'ha seguita nella quinta sezione, di fronte alla sala sampa. Ed è qui che poco dopo avere appreso di avere vinto si è appoggiato ad una porta. Si è sentito male all'improvviso. E' stato soccorso dal
figlio Gino, dal suo sostituto e da alcuni colleghi. E' stato adagiato su di una panca. Il figlio ha cercato di soccorrerlo. Pochi minuti dopo è stato chiesto l'intervento del prof. De Sando, un medico, perito del Tribunale, che si trovava per caso nei paraggi. Il sanitario ha cercato di pratica il massaggio cardiaco. Purtroppo, senza risultati. E' stato chiesto anche l'intervento di un'ambulanza, essendo il Palazzo di Giustizia sprovvisto di un pronto soccorso: è arrivata solo dopo mezz'ora, quando l'avvocato Favino aveva ormai cessato di vivere. Il corpo è stato coperto con la stessa toga che il
legale aveva indossato nel corso dei numerosi processi che lo avevano visto protagonista, ora nelle difese, ora nelle parti civili dei più clamorosi degli ultimi trenta anni. In segno di lutto, quando a Palazzo di Giustizia si è diffusa la notizia, sono state sospese tutte le udienze. Accertate le cause del decesso il magistrato ha concesso il nullaosta perchè la salma venisse consegnata ai familiari che hanno allestito la camera ardente nello studio di Via Attilio Regolo. L'avvocato Alfonso Favino era stato uno dei primi a sostenere la difesa in un processo per autanasia: quello cntro Edmondo Guastamagna, che soppresse la moglie gravemente malata. Fece parte della difesa anche nel processo contro la "famiglia maledetta" che aveva visto il fratello Ciancotti alla sbarra. Anche il processo contro i frati di Albano (storia di contrabbando) lo vide al banco dei difensori. Come anche nel clamoroso e doloroso processo di Via Gatteschi, in cui persero la vita i fratelli Gabriele e Silvano Menegazzo. In quell'occasione difese Franco Torregiani. Nel processo De Lellis invece il suo sapere giuridico lo mise in atto per difendere Dana Benjalin. Un altro processo clamoroso del passato lo vide tra i principali del Foro romano difendere nel caso Montesi lo "zio Giuseppe". Un'altra sua difesa vittoriosa era stata quella di Maria Naccarato per il processo delle sbische. E poi tanti altri processi più o meno di risonanza, lo videro protagonista, spesso con successo.
NOTE: L'ARTICOLO E' STATO PUBBLICATO SOLO IN ITALLIA DA "IL MESSAGGERO" IN DATA 25 SETTEMBRE 1982. Nell’occasione del 34° Anniversario della scomparsa dell’indimenticabile penalista Alfonso Favino, rivede la luce su questo sito l’opera: “I DUE VOLTI DEL PROFESSORE”, il romanzo che tanto fu apprezzato nel mondo forense. (Roma 24 settembre 1982 – Roma 24 settembre 2016)
Alfonso Favino
I DUE VOLTI DEL PROFESSORE
Romanzo
PRESENTAZIONE: “I due volti del professore” è un racconto affascinante e terribile, dalla trama carica di suspense. L’autore, penalista insigne, tratta anche argomenti e problemi di scottante attualità: dalla delinquenza patologica a quella violenta, dalla gioventù alla droga, alla guerra; in una visione della vita che ha per vocazione e destino l’amore, tanto amore. E’ un libro originale che mi esalta, anche perché chi l’ha scritto è come me un avvocato. Oltre l’impegno letterario, rivela una preparazione scientifica che lo farà certamente considerare un’opera di eccezione, da leggere e rileggere. (Giuseppe Sotgiu).
L’autore precisa che nomi e cognomi dei personaggi o di società della vicenda, che qui si narra, devono considerarsi involontarie e casuali omonimie con persone o società eventualmente esistenti.
I° CAPITOLO
Nell’anno scolastico 1978-79, un istituto parificato – che indicheremo con la lettera F. – in Roma, e precisamente nell’aula magna, in cui sono riuniti gli alunni di diverse sezioni del liceo classico e scientifico, particolarmente attenti alla lezione del professore Piero Pardi, trentanove anni, insegnante di storia e filosofia, originale, molto originale, e veramente a cuore a quei discepoli. Le giovani ne sono affascinante, i maschi lo ammirano per la sua sicurezza e la cultura, la chiara esposizione, la fantasia vivida. Nel corso degli studi, una due volte al mese, Pardi svolge, dinanzi a più classi riunite, un tema libero, particolare e con riflessi generali; tema libero in apparenza, più che nella sostanza, ossia fuori degli schemi dei testi scolastici. Nell’aula magna, oggi, verso la fine di ottobre, il professore si intrattiene sull’io fisico: suoi aspetti. Ed ecco la lezione, o conversazione, come egli suole definirla, che dice con voce suadente. Se ne riferisce qualche passo.
“E’ un tema, o meglio sarebbe dire un problema eterno quello dell’io, di questo nostro io che portiamo con noi, che noi siamo e che anzi ci porta il nostro corpo. Quando non ci piace, è difficile, molto difficile per non dire impossibile, modificarlo, renderlo conforme ai nostri desideri, al nostro ideale o sogno, perchù tutti vorrebbero essere belli, a modo proprio attraenti. E, invece, è così, e non diverso, come se il destino lo abbia voluto, e certamente non la nostra volontà e intelligenza, il gusto, la finezza, la sensibilità, propri di ciascuno di noi. Era scritto nelle cellule germinali degli ascendenti: il nastro magnetico del nostro futuro io. Quindi lo giudichiamo e può persino apparirci come un estraneo, o essere tutt’altro che gradito, per vari aspetti, alla nostra intimità profonda. Si potrebbero fare cento e cento esempi per dire che non sempre il corpo nostro ci garba, o che anzi ci dispiace, anche tanto, e si arriva a soffrire di essere brutti. Sì, non c’è dubbio, è un fatto certo e cocciuto che una delle cause di infelicità a questo mondo – non son in pochi a dolersene – viene dal dispiacere di questo eterno nostro amico-nemico quando ci è sgradevole, per le sue deficienze.
Michelangelo, artista sommo, pativa una tale umiliazione, a suo dire, come egli stesso ricorda in uno dei suoi madrigali:
“Ben par che ‘l ciel s’adiri / che ’n sì begli occhi i’mi vegga sì bructo…”
E della bellezza, in particolare dell’uomo, il Buonarroti ebbe tanto e così ardente desiderio. Ricordate i suoi versi?
“La forza di un bel viso a che mi sprona! / C’altro non ha c’al mondo mi dilecti…”
Tanto desiderio, quanto inesaudito per se stesso, che il ‘bel viso’ Michelangelo amava ricercare negli amici, nei discepoli di cui si circondava, oltre che immortalarlo nelle sue opere. Così si spiega un caso, non infrequente, di omosessualità ideale. Chi si dispiace e soffre della propria figura, o immagine corporea, è certo che gli altri a loro volta non se ne compiacciono e la rifiutano, ed è per questi convincimenti che a livello dell’io profondo, specie nei più sensibili, dalla fanciullezza e forse da prima, si instaura una sorta di contrarietà se non di tristezza, e che si incide nel carattere, instilla la malinconia, i tormenti; nei più deboli possono derivare frustrazioni, complessi, aggressività, disturbi psichici… Quanto ne sanno medici, psicanalisti, psichiatri!
Con mio vivo compiacimento constato che il problema, di cui si parla, neanche sfiora voi qui presenti, amici cari; nei vostri volti splende il sorriso dell’adolescenza, della giovinezza felice. Degli alunni qualcuno ride, qualcuno applaude, c’è chi chiama in causa questo o quel condiscepolo per irriderlo. Il professore riprende. “E’ anche vero che, quando il nostro corpo non ci aggrada, si cerca di fargli assumere un aspetto, un’espressione, nei limiti del possibile, diversi dal naturale, più consoni alle nostre aspirazioni. Ed è l’altro io, spirituale, che si impegna con buona lena per apportare cambiamenti, e quasi modellarne un altro. Quanto cure, quante attenzioni, specie dalle donne, che pazienza! Oggi poi che si sono fatti anche passi da gigante con le scienze mediche e la chirurgia plastica. Ed è possibile, indirettamente, superare l’handicap dei difetti o carenze del nostro fisico, reagendo e supplendovi con le realizzazioni e le conquiste dell’altro io, spirituale, che con la sua volontà e la sua intelligenza, con le applicazioni tenaci può vincere le delusioni e le sconfitte, si fa per dire, del suo indivisibile compagno, riuscendo ad affermarsi e giungere al successo, piccolo o grande, persino alla gloria, anche a costo di rinunce, sacrifici, sofferenze. Ed è commovente la partecipazione e collaborazione di quel corpo che si acconcia, si piega e affatica consapevole di essere la causa o una delle cause di tanto impegno; ma ne è ripagato perché una volta raggiunta a méta o conseguito il successo, finanche il suo ‘bructo’ può attenuarsi o anche più non vedersi per lo meno dagli altri. Questa condizione felice è la rivincita dello spirito sulla materia.
Chi non ricorda il Leopardi? Sublimò, certamente, anche la sua deformità fisica nei suoi Canti immortali. E non si dica che abbiamo dimenticato di parlare della donna. Di proposito, al contrario, ne abbiamo quasi taciuto finora, perché rivendichiamo all’altro sesso la parità dei diritti a cominciare dal diritto di non essere belle; sì, proprio così, ovvero di non essere l’oggetto esclusivo o predominante del piacere del maschio, il quale, per lo più oggi, per una errata valutazione ed educazione sessuale, insegue e persegue unicamente la femmina per il godimento sensuale. La donna come l’uomo, parimenti con l’uomo, non ha l’obbligo di essere bella, bensì ne ha diritto, come e quando a lei conviene e seconda; e certamente le sarà sempre grata la leggiadrìa delle proprie forme. Le creature sexy esistano pure in tutti e due i generi; l’ideale è la comunione dei corpi fino a quella degli spiriti. E vi ricordo che la nostra compagna gode di un privilegio bellissimo: il dono di altre vite. Quanta amabilità e grazia nelle delicate sembianze di una madre; quanta luce nel suo sorriso!”. Il professore così conclude la sua lezione:
“infine, v’è un riscatto per tutti, una via immediata, diretta, che salva e può dare la felicità a chiunque, quali che siano i difetti, minorazioni o fin degradazione del proprio corpo, e le
inquietudini che li accompagnano: è l’amore. Ciascuno porta in sé l’originale – idea o desiderio – della propria bellezza, ne cerca nel mondo la copia. Dell’amore parleremo la prossima volta.”
Piero Pardi risponde con ampi gesti delle mani al cordiale saluto degli alunni, i quali lasciano l’aula più o meno commentando in vario modo la lezione. Il giovane Stori, alla sua collega Napoli,
sempre composta e graziosa, dice: “Ma, insomma, io non ho capito bene, per avere successo bisogna essere brutti, o belli?” Il giovane Del Vecchio fa: “Ho ben capito, Mariani, tanto brutto, può far di Michelangelo.” E il Ferrino: “No, no; non vi illudete, ragazzi, per nostra fortuna il bello viene la prossima volta, non c’è dubbio: ma l’amore possiamo subito cominciarlo, è la cosa più bella che ci sia al mondo, non è vero, Matilde?” E si abbraccia a Matilde S., una condiscepola non indifferente ai complimenti concreti. A sua volta Cavalli, il piccoletto del 4° scientifico, si avvicina a Cecilia, 2° liceo classico, leziosa e dolce, e le dice: “Tu sei nata madre, mia cara, quanto sei bella, da sempre!” E Cecilia gli dà un bacio. Pardi ascolta, vede, si allontana evitando gruppetti di genitori lungo i corridoi,
specie le mamme che gli rivolgono particolari attenzioni; ché il nostro professore a proposito di brutti e belli, è doveroso riconoscere, è, come si dice, un bell’uomo, anche se freddo, e “riservato come un gatto”, così lo ha definito una di quelle mamme. Comunque, oggi non è il giorno di ricevimento dei genitori; ed egli di corsa, come al solito, si infila nella sua auto, di lì a poco giunge alla porta di un villino ai Parioli, ombreggiato da alberi di alto fusto. Sale al 2° piano, si ferma davanti all’interno 4, con chiave apre la porta – sulla cui targhetta si legge: “Anonima Parioli s.r.l.” – entra in sala d’aspetto, passa in una stanza dove c’è una giovane segretaria – già pronta per andar via, sono le 13 circa – la quale saluta: “Buongiorno, dottore.” Pardi risponde: “Buongiorno, Mitzi, c’è Silvano?.” “No, c’è la signora Miscèl.” Il professore va in una stanza attigua, da Miscèl, la saluta come pensando ad altro e chiede se ci sono novità. Miscèl, una bruna elegante, dal viso teso, gli occhi espressivi,
assicuratasi che la segretaria è già uscita, si avvicina a Pardi e a bassa voce risponde: “Sono semplici e non favorevoli. La polizia, secondo le ultime informazioni, è quasi certo, per non dire certo,
che sappia della partita di… in partenza da Nuova Delhi.” Infatti, da questa città per via aerea dovrebbe arrivare a Roma un grosso quantitativo di droga pesante, eroina. “Ma donde possono venire sospetti del genere?” domanda Pardi, e poi: “Silvano quando rientra?” “Non ti preoccupare pero” risponde Miscèl “abbiamo telegrafato in cifrato a Nuova Delhi di passare la roba a nostra persona che salirà sull’aereo a Palermo.” “Ci andrò io” dice Pardi, come parlando a se stesso. “Ma, forse, è preferibile” dice Miscél, “che ci vada Silvano, o anche Ermanno, rimandando il volo anche di un giorno, non ha importanza.” “No, vado io” insiste Pardi “questa è l’occasione buona per realizzare…” Non termina Pardi che entra in ufficio – l’appartamento, infatti, è un ufficio di import-export – Silvano, fratello di Miscèl, come al solito rumoroso ed eccitato a cominciare dalla voce sonora e profonda. “E allora” chiede Silvano a Pardi “ha saputo?” “Sì, da Miscèl ho saputo, e non c’è che una soluzione: raggiungere, appena possibile, Palermo. Provvederò io a portare ogni cosa a buon fine; purché siate stati chiari nell’intesa attraverso il cifrario.” Miscèl ha da dire qualcosa, interviene anche lei, e di nuovo consiglia che il viaggio lo faccia Silvano, delle cui capacità di prontezza e disinvoltura, di audacia e colpo d’occhio ha grande considerazione e conoscenza dalla nascita, ché Silvano, ripetesi, è suo fratello. “No” ribatte Pardi “se la polizia è all’erta, all’aeroporto di Palermo Silvano potrebbe dar nell’occhio di qualche vecchia conoscenza… di poliziotto.” “No!” scatta Silvano “ma no, è ora di finirla con questa mia vecchia storiella di pregiudicato; volete ficcarvi in mente una buona volta, perdio, che sono un riabilitato? RIABILITATO!!! Come attesta questo foglio, che porto sempre con me, della Corte di Appello.” E agita un verbale di giudice, per convincere soprattutto se stesso; in realtà, invece, anche lui pensa che sia preferibile vada a Palermo persona non sfiorata dal minimo sospetto a occhi polizieschi. A Palermo andrà Pardi. (fine del I° capitolo)
La sfera dei principi
di Luigi Favino
PUBBLICAZIONE DI INTERCETTAZIONI E VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI". Il concetto, come si sa, è una costruzione logica intesa a definire l'esistenza delle cose. Molti istituti giuridici derivano da concetti tradotti in norme di legge. Il diritto asseconda l'assolutezza connaturata alla figura del concetto poichè in relazione al valore considerato è in grado di modulare la propria produzione precettiva comprendendovi ogni profilo, il più e il meno, il nero e il bianco, il genere e la specie, sicchè si può dire che tra tutte le categorie dello spirito il diritto è quella che meglio attualizza la sfera dei principi. Prendiamo il cosiddetto garantismo, ovverosia la concezione concernente il sistema delle garanzie individuali nei confronti del "potere": esso designa il giusto equilibrio tra interesse particolare ed interesse generale, fra il singolo e lo Stato, e ripone nella tutela e nel rispetto dei diritti della persona, la quintessenza della società moderna e dello sviluppo e il logo di una legislazione assoluta. Nella dialettica politica il garantismo è diventato il discriminante tra progresso e conservazione e, pur contraddizioni talora plateali, rappresenta il passaggio più cruciale
dell'ordinamento. Qui l'assolutezza del concetto nella sua transizione verso il reale, mostra qualche crepa, nel senso che, dietro lo schermo di alcune pur necessarie normative d'eccezione, il confine tra l'interventismo del "potere" e i diritti dell'individuo si va dissolvendo, tanto che il reticolo delle garanzie, faticosamente costruito in decennia di elaborazione della dottrina e della giurisprudenza, si fa di giorno più fragile fino a svanire. E' il caso della libertà di stampa nel processo penale in Italia, che ormai di fatto sovrabbonda a detrimento della dignità e dei diritti delle persone ad opera
di media sempre più disposti a rovistare dappertutto nella ricerca di notizie originali a tutti i costi, molto spesso al limite, sia della decenza, che soprattutto, della qualità dell'informazione. Di qui la sensazione, ma anche la certezza, che molti siano favorevoli ad un cambiamento radicale della normative che impunemente permette a giornali e settimanali la pubblicazione continua di paginate anche di intercettazioni telefoniche, contenenti “gossip” e pettegolezzi sulla vita private delle persone, intercettazioni che occupano chi le esegue ventiquattro ore su ventiquattro ed impegnano nel contempo, notevoli stanziamenti di fondi da parte dello Stato. Tuttavia, proprio recentemente doveva andare in porto il progetto di legge sull’argomento, l’ultimo della serie, che il governo discute ormai inutilmente da anni, limitandolo, modificandolo e restringendolo per il muro contro muro delle opposizioni, in nome di una libertà astratta quanto ingiusta, in una materia che non ammette troppe libertà: quella del processo penale. Ma non se ne è fatto niente. Il vaglio finale della Commissione Giustizia che doveva avvenire al Massimo entro l’estate prevedeva il divieto di pubblicazione anche in forma riassuntiva di qualsiasi atto di un procedimento giudiziario fino al termine dell’udienza preliminare, anche se non più coperto dal segreto istruttorio. E non sarebbe stato neppure possibile pubblicare tutte quelle
intercettazioni di cui sia stata ordinata la distruzione, perchè magari qualcuna poteva riguardare fatti, circostanze e nomi estranee alle indagini. Sarebbero stati pubblicati le cosiddette ordinanze di custodia cautelare, i vecchi mandati di cattura, per intenderci, ma soltanto dopo che l’indagato o il suo difensore ne fossero stati informati. Inoltre, per far scattare l’autorizzazione agli ascolti delle telefonate, ci sarebbe voluta la decisione di un Giudice Collegiale; e soprattutto si tornava al presupposto degli indizi “gravi” di reato; per cui non sarebbe stata più valida la formula precedentemente adottata, degli “evidenti indizi di colpevolezza” che poteva ingenerare non poche confusioni ed abusi.
NOTE: L'ARTICOLO E' STATO PUBBLICATO SOLO IN ITALIA, SI VALUTANO RICHIESTE DI PUBBLICAZIONE SU STAMPA ESTERA
2007 - La spy story Ferrari-MacLaren. In meno di un anno chiuse le inchieste, accertata la verità, eseguita la sentenza
di Luigi Favino
Sommario: 1) Il furto di documenti telematici e le tre istruttorie contro la Mac Laren; 2) Dal Consiglio FIA di Parigi e quello Mondiale con la sentenza di
condanna della Casa a 100 milioni di dollari di ammenda e alla penalizzazione di 166 punti; 3) La confessione del responsabile della Mac Laren e l'esecuzione
della sentenza che aveva salvato i piloti.
IL FURTO DI DOCUMENTI TELEMATICI E LE TRE ISTRUTTORIE CONTRO LA MAC LAREN". La nostra giustizia dovrà ispirarsi sempre più a quella
internazionale per risolvere brillantemente ed in poco tempo le questioni giuridiche più complesse e delicate, senza inutili e defatiganti processi infiniti,
dopo l'esito di questa spy story che ha appassionato il grande pubblico sui media e sulle pagine sportive dei giornali. Vale la pena ripercorrere in una breve
sintesi le tappe essenziali di questo avvincente caso di spionaggio industriale e sportivo insieme, dal trafugamento dei documenti tecnici della Ferrari contenuti
in un CD ad opera della Mac Laren; un fatto da cui presero le mosse, nel 2007, contemporaneamente tre inchieste: quella della FIA (Federazione Internazionale
dell'Automobile) da una parte, e quello dei Tribunali di Londra e Modena dall'altra. Esattamente il 22 giugno di quell'anno la Ferrari deposita alla Procura
presso il Tribunale di Modena un esposto per furto di documenti nei confronti del suo ex tecnico Nigel Stepney, per il reato di tentato sabotaggio durante
il G.P. di Monaco che aveva portato la polizia postale a perquisire, dopo qualche giorno, la dell'ex tecnico ferrarista, subito licenziato dalla Casa di Maranello.
Con un'inchiesta parallela la FIA metteva sotto accusa la scuderia Mac Laren perchè i disegni contenuti nei documenti trafugati avrebbero potuto giovarle, per cui
la deferiva al Consiglio Mondiale a Parigi per violazione delle regole sportive e più precisamente dell'art. 151 del Codice FIA che punisce il possesso illecito
di informazioni confidenziali. Contemporaneamente si apriva a Londra presso la Hig Court un procedimento intentato dalla Ferrari contro Mike Coughlan, il capo
ingegnere che la Mac Laren aveva sospeso all'inizio dello scandalo, perchè trovato in possesso di documenti col marchio Ferrari. In sintesi le accuse consistevano
nei reati di "furto di informazioni tecniche" sottratte alla Ferrari e di "spionaggio", addebitati rispettivamente allo Stepney e al Coughlan nella sua veste di
ingegnere progettista delal Mac Laren. E' da specificare poi che le auto che correvano in quel periodo erano la Ferrari F/2007 e la Mac Laren MP4/22, due auto
assolutamente diverse tra loro, per cui sembrava impossibile che dai disegni contenuti in quei documenti la scuderia inglese potesse copiare soluzioni fruibili
o quanto meno significative. Ed è ancora da aggiungere che figuravano agli atti le intercettazioni di conversazioni telefoniche tra Stepney e Coughlan aventi
per oggetto i presunti segreti Ferrari, risultando complessivamente 780 le pagine dell'incarto processuale. Furono inoltre le dichiarazioni del Direttore Generale
della Honda, Nick Fry, secondo cui Stepney e Coughlan lo avevano contattato per chiedere un ingaggio per un nuovo lavoro, ad alimentare il forte sospetto
della fondatezza delle accuse. Intervistato il 12 luglio 2007 dal giornalista Fabio Rubini di Libero, Giancarlo Minardi, ex pilota di Formula Uno ed oggi
opinionista di Sky, si espresse così sul punto cruciale della sottrazione dei documenti alla Ferrari: "Noi eravamo una piccola scuderia, ma con tecnici molto
bravi che quando se ne andavano portavano con sè la proprietà intellettuale delle loro intuizioni, ma furti di disegni non me ne ricordo. In passato era molto
difficile trafugare documenti, infilarli in una borsa e portarli via. Oggi basta mettersi in tasca un dischetto o una penna USB per portarsi via un sacco di documenti.
I disegni contenuti in quei documenti secondo ma rappresentano il danno minimo per la Ferrari, il punto vero è un altro. Le procedure industriali dei vari processi
della scuderia - è questo il vero danno, perchè uno dei punti di forza della Ferrari sta proprio nello sviluppo estremo di queste procedure".
DAL CONSIGLIO FIA DI PARIGI A QUELO MONDIALE CON LA SENTENZA DI CONDANNA DELLA CASA A 100 MILIONI DI DOLLARI DI
AMMENDA E ALLA PENALIZZAZIONE DI 166 PUNTI. Prima della decisione della FIA, la Ferrari e Coughlan avrebbero trovato
un accordo in questi termini: l’inglese avrebbe consegnato un memoriale contenente la verità sul trafugamento di documenti che
poi la Ferrari si sarebbe tenuta per sé, abbandonando ogni velleità di giustizia penale in Italia e all’estero contro la scuderia
della Mc Laren presieduta da Roned Dennis. La decisione del Consiglio di Parigi della FIA, non si fece attendere, perché il 26
luglio dello stesso anno, stabiliva di non emettere alcuna sanzione alla Mac Laren pur ritenendola colpevole della detenzione delle
informazioni tecniche sottratte alla Ferrari, per mancanza di prove circa un fruttuoso utilizzo da parte della stessa della tattica
di gara delle vetture di Maranello. Si erano così avverate le previsioni anticipate di Bernie Ecclestone, il patron della Formula Uno,
in un intervista al Times nel pieno evolversi dello scandalo: “I piloti della Mac Laren non c’entrano in questa storia e per questo
non rischiano nessuna penalizzazione in termini di punti; se poi dovessero essere accertate responsabilità oggettive la sola scuderia
Mac Laren rischierebbe una penalizzazione nel Campionato Costruttori, sempre che – proseguiva Ecclestone puntualmente intervistato da
Fabio Rubini (Libero 6 luglio 2007 p.39) – le informazioni sottratte siano state usate e dopo avere accertato in che modo abbiano
influenzato la prestazione della Mac Laren ed in quali circostanze”. La decisione della FIA sollevò le proteste della Federazione
Italiana, al punto che l’organismo internazionale si vide costretto ad appellare la sua decisione per il ricorso di Jean Todt; anche
se qualcuno rimproverò a quest’ultimo il fatto di non avere ritirato, dopo la sentenza di Parigi, tutta la squadra Ferrari dal
Campionato di Formula Uno, così come Enzo Ferrari rinunciò alla conquista del secondo titolo mondiale con John Surtees, liquidato
su due piedi nel 1966 dal “Drake” all’indomani della vittoria con la rossa nel Gran Premio del Belgio, solo perché sospettato di
avere in qualche modo trasmesso agli amici della Lola qualche particolare tecnico delle vetture classificato top secret. Venuta
in possesso di nuovi argomenti probatori, la FIA decise di annullare l’udienza di appello e di riaprire il caso al Consiglio Mondiale
di Parigi, composto da ventisei giudici. La sentenza anche in questo caso non si fece attendere ed il 13 settembre venne pronunziata
una condanna a metà che penalizzava di ben 166 punti la Mac Laren nel Mondiale Costruttori e le infliggeva una ammenda di 100 milioni
di dollari, ma che nel contempo mandava esenti i piloti Alonso ed Hamilton da qualsiasi penalità, mettendoli così in condizione di
poter proseguire il Campionato di Formula Uno. Una decisione ambigua, avrebbe detto qualcuno, perché pur riconoscendo la consumazione
di uno spionaggio ai danni della Ferrari per opera della Mac Laren, colpiva le macchine e risparmiava i piloti, ma che nel caso di
specie, secondo la sentenza, “si spiega con le circostanze eccezionali che hanno portato ad accordare una immunità ai piloti, vista
la loro collaborazione, e per aver portato degli elementi e delle prove non verranno tolti loro i punti”. La Ferrari ha dunque avuto
giustizia, mentre alla Mac Laren la storia è costata oltre ai cento milioni di dollari della pena pecuniaria, anche il mancato introito
di altri settanta milioni spettanti alla squadra vincitrice del Mondiale Costruttori. Tra l’altro, all’indomani della sentenza, erano
divenuti di dominio pubblico gli sms di Stepney alla Mac Laren durante le gare internazionali, che illustravano le strategie della
Ferrari, ed in grado di far modificare tempestivamente all’avversario la condotta da seguire nella gara. La polizia giudiziaria italiana
aveva infatti fornito i verbali ed i tabulati di tutto questo scambio di informazioni, ma anche tutte le telefonate e gli sms effettuati
da Stepney sul cellulare di Coughlan da marzo a luglio 2007, nonché le telefonate (35) e gli sms (ben 288) scambiati tra i due nel
periodo marzo-aprile 2007, concentratisi soprattutto in occasione dei test privati della Casa di Maranello in Malesia e nel Gran Premio
di Australia, ed infine delle e-mail (ben 23) tra Alonso e Pedro de la Rosa, collaudatore Mac Laren.
NOTE: L'ARTICOLO E' STATO PUBBLICATO SOLO IN ITALIA, SI VALUTANO RICHIESTE DI PUBBLICAZIONE SU STAMPA ESTERA
L'Europa dei diritti dell'Uomo tra Convenzioni internazionali ed immunità degli Stati Sovrani
di Luigi Favino
PREFAZIONE DELL'AVV. LORENZO QUADRI DEL FORO DI ROMA.
Il lavoro dell'avv. Luigi Favino analizza alcune interessanti convenzioni internazionali, tra le meno conosciute dal grosso pubblico in
materia di deroga alla giurisdizione penale dei tribunali ordinari, come quella ad esempio che ha permesso ai militari americani di stanza
in Italia di essere giudicati negli Stati Uniti per fatti relativi alla strage del Cermis di qualche anno fa. Cosa questa che non è
altrettanto avvenuta - sostiene l'avv. Favino - per la mancanza di una convenzione, nel caso dei due Marò italiani detenuti in India,
che avesse operato una deroga alla giurisdizione come quella americana del Trattato Nord-Atlantico. Il lavoro poi passa in rassegna altre
normative che hanno pur sempre ad oggetto uno scenario internazionale, il cui "trait d'union" è quello dei Diritti Umani e delle Libertà
fondamentali che l'autore dibatte riportando sentenze internazionali che riguardano materie di estreme attualità, come quelle del recente
divieto di arresto e carcerazione dei giornalisti, per nessun caso di violazione della Legge su stampa o dei reati ad essa connessi;
dal mandato di cattura europeo all'estradizione dei cittadini. Proprio la violazione dei Diritti Umani è
stata messa a fuoco in tutti quei recenti casi che si sono ulteriormente verificati per il contrasto drammatico e sproporzionato tra i
diritti dei singoli cittadini e quelli di soggetti forti, come gli Stati sovrani che non rinunciando all'immunità internazionale, hanno
impedito ai giudici di esercitare la giurisdizione penale e civile in materia di gravi crimini contro l'umanità e dei relativi risarcimenti
dei danni alle parti offese. In sostanza, il lavoro mette in luce le contraddizioni ancora laceranti, esistenti tra i diritti delle
convenzioni e la violazione degli stessi, in un'Europa che ancora deve finire di formarsi.
1) Premessa.
2) Il Trattato Nord-Atlantico (L. 30 novembre 1955 n.1335) sulle Forze Armate.
3) La Convenzione di Vienna 18 aprile 1961 sull’immunità internazionale degli agenti diplomatici.
4) La Convenzione Internazionale sugli italiani detenuti e condannati all’estero.
5) La Legge sulle assicurazioni dei veicoli con targa straniera circolanti in Italia.
6) Il mandato di arresto europeo in vista dell’estradizione.
7) La sentenza 3 febbraio 2012 della Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja sui crimini contro l’umanità: esclusa la giurisdizione
civile e penale dell’Italia per l’immunità internazionale degli stati sovrani.
8) Il no della Corte di Strasburgo alle pene detentive per i giornalisti.
9) La giurisdizione militare italiana fra proposte di riforma normativa ed il “GAP” di una legittima Giustizia Internazionale malgrado
il forte incremento delle Missioni di pace all’Estero.
1) PREMESSA
Dai primi anni novecento è cominciato un fiorire di normative e convenzioni internazionali nelle più disparate materie, sulla spinta dei due dopoguerra che hanno visto gli Stati
riallinearsi tra loro, per dar vita finalmente negli anni cinquanta, ad una sorta di diritto naturale per troppo tempo trascurato ed a riordinare quelli che sarebbero poi divenuti
i diritti fondamentali della persona: dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo firmata a Ginevra nel 1948, alla successiva e più importante Convenzione per la salvaguardia
dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950,sino al Patto Internazionale sul Diritti Civili e Politici approvato dall’Assemblea Generale
dell’ONU nella seduta del 16 dicembre 1966. Da allora sono nate relazioni sovranazionali per nuovi accordi economici e sociali, come il Trattato di Roma del 1957, che poneva le
basi di quella che sarebbe divenuta la nuova Europa. Non a caso Konrad Adenauer il 15 dicembre 1954 disse: “Die Einhet Europas war ein Traum von wenigen. Sie wurde eine Hoffnung
ffur viele. Sie ist heute eine Notwendigkeit fur uns alle.” (L’Unione dell’Europa è stata un sogno di pochi, ma è diventata una speranza per molti. Ed oggi è una necessità per tutti.).
Quella del Trattato perfezionato nel Febbraio 1986 dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri della Comunità Europea, il cosiddetto Atto Unico Europeo con il quale gli stessi
Paesi hanno voluto da una parte riformare le Comunità Europee (la Comunità Europea del carbone e dell’acciaio “CECA” , la Comunità Economica Europea “CEE” e la Comunità Europea
dell’Energia Atomica “EURATOM” e dall’altra coordinare le diverse tendenze politiche per attuare, come obbiettivo ultimo, l’Unione Europea, al di là di una mera Unione Doganale.
Ma prima di tutto questo programma ambizioso, che presuppone una stretta coesione tra tutti gli Stati membri, la “prima Europa”, che ancora non c’era sulla carta, si occupò del
Trattato Nord-Atlantico che nel 1955 introdusse la normativa speciale per i processi ai militari imputati nel territorio di uno Stato “dove essi risiedono temporaneamente come
truppe di occupazione o per altri motivi, con il consenso dello Stato di soggiorno”.
Parimenti la Convenzione di Vienna sugli agenti diplomatici del 1961 riguardava altre eccezioni alla giurisdizione penale ordinaria, relativamente all’immunità processuale di
questi soggetti, sia in ambito europeo che extraeuropeo.
Un’altra deroga alla giurisdizione civile e penale italiana è stata affermata di recente dalla Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja (3 febbraio 2012) con una decisione che
ha fatto discutere perché ha reso inefficaci due sentenze della nostra Cassazione sull’immunità dello Stato Tedesco e sulla violazione dei diritti inviolabili della persona.
Anche interessante inoltre la normativa varata sul mandato di arresto europeo in vista dell’estradizione, che per una sintesi più pratica abbiamo ritenuto illustrare riferendoci
espressamente ad un caso avvenuto in ambito squisitamente europeo, e precisamente alla sentenza (n.4614 delle Sezioni Unite Penali della Cassazione del 2007), redatta in modo molto
chiaro e comprensibile. Sempre in materia di arresti poi, abbiamo riportato la sintesi delle due storiche decisioni della Corte di Strasburgo del 2013 sulla libertà di Stampa ed
il divieto di condanne detentive automatiche per i giornalisti.
Interessante e poco nota ai più la Convenzione Internazionale sugli Italiani detenuti e condannati all’estero del 1989; ed anche di quel periodo, ma non meno interessante è la
L. 242 del 1990, sull’obbligo assicurativo per la responsabilità civile dei veicoli con targa estera circolanti in Italia.
Un’ultima nota riguarda la giurisdizione militare, peraltro prevista dalla nostra Costituzione in parallelo con quella ordinaria, ma che si vorrebbe riformare anche per l’incremento
avuto dalle nostre Missioni militari di pace all’Estero.
Tutti questi argomenti nascenti da accordi, convenzioni e sentenze di una certa importanza hanno sicuramente dei profili Europei, ma non costituiscono tuttavia un vero e proprio
Diritto Europeo, perché non esiste ancora un organico Diritto Penale Europeo che tenga conto dei codici e della legislazione penale dei singoli Stati, almeno di quelli che sono
uniformi sugli istituti più importanti. Come del resto aveva sentenziato Robert Schuman il 9 maggio 1950: “L’Europa non potrà farsi in una sola volta, ne sarà costruita tutta insieme;
essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto”.
Come non esistono ancora delle vere e proprie Istituzioni Europee esenti da quella inutile burocrazia dei tanti apparati amministrativi, in grado di eliminare tutte le contraddizioni
in materia di personalismi ed immunità internazionali dei singoli Stati.
Con l’Europa della Dichiarazione Universale dei Diritti del 1948 e della successiva Convenzione dei Diritti dell’Uomo e della Salvaguardia delle Libertà Fondamentali, sono del tutto
in linea le decisioni di Strasburgo, prima fra tutte, quella sulla eliminazione del carcere a tutti i giornalisti. Nonché l’altra relativa alla condanna dell’Italia per il sovraffollamento
delle carceri: in particolare la sentenza dell’8 gennaio 2013 (Mino Torreggiani) di condanna per il trattamento inumano e degradante in violazione dell’art.3 Convenzione dei Diritti
dell’Uomo ha invitato l’ “Italia a risolvere il problema strutturale di sovraffollamento delle carceri, incompatibile con la Convenzione U.E.”. Ed ancora con la stessa Europa dei diritti umani,
non sono affatto in linea: da una parte il pluriennale abbandono del nostro Paese a gestire da solo il sovraffollamento degli emigranti stranieri sulle nostre coste, e dall’altra parte,
a non avere trovato la soluzione giudiziaria dello sfortunato caso dei due nostri militari La Torre e Girone, dopo tre anni dall’accaduto. Questi, come è a tutti noto, pur essendo impegnati
in una Missione di pace NATO contro la pirateria in acque internazionali, a bordo di una nave mercantile, non sono stati giudicati dal competente Tribunale Internazionale del Diritto del Mare
(organismo internazionale dell’ONU con sede ad Amburgo per dirimere i contenziosi specifici tra centoquarantanove Nazioni aderenti), oppure dalla Corte Internazionale di Giustizia,
come è accaduto in altri casi.
Tutto ciò lascia intravedere, sia pure a titolo omissivo, un quadro pieno di contraddizioni nella politica e nella normativa di intervento della U.E. Giustamente sosteneva il 22 gennaio 1944
Altiero Spinelli: “Evidentemente non basta che un ordinamento federale abbia meriti intrinseci. Perché venga realizzato, occorre vedere se intorno ad esso, a suo sostegno permanente, ci sia
da attendersi che si schierino, nella civiltà moderna, imponenti forze vitali e, per farsi valere, sentano di aver bisogno di quell’ordinamento e siano perciò disposte ad agire per mantenerlo in vigore”.
D’altro canto se “prima facie” appaiono ormai superate tutte quelle deroghe giurisdizionali per le Convenzioni, cui si è accennato, pur tuttavia sulle immunità diplomatiche e militari,
per ragioni di sicurezza e di opportunità anche sul piano della reciprocità internazionale, non vi si può rinunciare.
Costituiscono invece delle vere e proprie violazioni dei diritti umani verso i singoli cittadini europei, sentenze come quella riportata dalla Corte dell’Aja che ha fatto prevalere l’immunità
dello Stato sovrano ignorando la violazione dei diritti della persona dei singoli cittadini.
Di qui la necessità che una “seconda Europa” possa meglio bilanciare questi conflitti ed interessi oggi insuperabili sul piano del diritto e della giustizia. “E’ la volontà politica ordinaria –
diceva in un discorso del 16 dicembre 1952 Alcide de Gasperi – che deve prevalere. E’ imperativo categorico che bisogna fare l’Europa, per assicurare la nostra pace, il nostro progresso e la
nostra giustizia sociale, che deve anzitutto servirci di guida”.
2) IL TRATTATO NORD-ATLANTICO (L. 30 NOVEMBRE 1955 N.1335) SULLE FORZE ARMATE
Successivo di pochi anni alla più nota Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali(firmata a Roma il 4 novembre 1950), è il Trattato Nord-atlantico sullo
“status” delle “loro” forze armate, firmato a Londra e tuttora in vigore con l’istituzione di una giurisdizione concorrente, che prevede la possibilità per lo Stato di soggiorno di rinunziare
al diritto di esercitare la propria giurisdizione a favore dello Stato di origine del militare accusato di un delitto o di un reato, in base al principio c.d. della “giurisdizione della bandiera”,
cui si ispira l’art. VII della Convenzione di Londra recepita con la L. 30 novembre 1955, n.1335 da parte dello Stato Italiano, (come avvenuto nel caso del Cermis e dei fatti commessi dalle Forze
Alleate in Italia nel periodo postbellico).
Il principio, infatti, si presenta applicabile non soltanto alle truppe di “occupazione”, ma anche in via più generale a tutte le Forze Armate di uno Stato estero che per qualsiasi motivo transitino
o stazionino nel territorio dello Stato di soggiorno, con il consenso di quest’ultimo.
Questa normativa va considerata come un completamento del famoso Patto Atlantico del 1949, che ancora oggi è oggetto di discussione in congressi e conferenze e che dai più è stato giustificato ed
interpretato come una necessità militare, mentre per altri come una imposizione politica (v. per tutti l’Incontro sullo specifico argomento di cui sopra, dibattuto alla LUMSA il 13 novembre 2009,
dall’Unione Giuristi Cattolici Italiani, dal tema: “Il Patto Atlantico imposizione politica o necessità militare?”). Basti rileggere infatti l’art. 5 del citato Patto che letteralmente riporta:
“Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell’America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono
che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell’esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall’art. 51 dello Stato delle Nazioni Unite, assisterà
la parte o le parti così attaccate, intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l’azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l’uso della forza armata, per
ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell’Atlantico settentrionale.
Ogni attacco armato di questo genere e tutte le misure prese in conseguenza di esso saranno immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza. Queste misure termineranno allorché il
Consiglio di Sicurezza avrà preso le misure necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali”. In base allo spirito informatore del testo legislativo internazionale
sopra richiamato, non sembra contestabile l’opportunità, nelle ipotesi, ivi previste, di una rinuncia da parte degli organi giurisdizionali del Paese “ospitante” a conoscere i fatti che interessano
il Paese d’origine dei loro autori. In altre parole, ogni qualvolta il caso che si presenta trascenda l’ambito strettamente giudiziario, dilatandosi in un campo politico di collaborazione internazionale
di organismi che perseguano finalità di relazioni superstatuali, necessita dar vita a soluzioni ponderate e soprattutto conformi ad interessi superiori e trascendenti quella specifica vicenda
giudiziaria: si faccia ad esempio l’ipotesi di imputati militari appartenenti alle Forze NATO ed operanti nel territorio di un Paese aderente alla NATO stessa, ma dipendente funzionalmente dai
rispettivi comandi, per cui quanto di illecito penale da questi eventualmente commesso non può interessare lo Stato ospitante, ma unicamente e personalmente gli organi esteri a loro preposti.
E’ ancora da notare che ogni qualvolta (n.9 del citato articolo) il procedimento viene celebrato avanti ad un organo giurisdizionale dello Stato di soggiorno, l’imputato ha diritto ad essere giudicato
rapidamente; ad essere informato prima del dibattimento dell’accusa che gli viene mossa; ad essere posto a confronto con i testi a carico; ad essere assistito da un avvocato di propria scelta secondo
le norme processuali vigenti nello Stato di soggiorno, nonché a servirsi di un interprete; ad essere posto in contatto con un rappresentante del governo dello Stato di origine ed a pretendere, ove il
rito lo consenta, la presenza di tale rappresentante al dibattimento (ecc. ecc.).
E’ chiara l’importanza di questa normativa, presa integralmente dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti Umani sopra menzionata, proprio per la maggiore tutela di quei diritti in sede
giudiziaria. Ancora va tenuta presente la L. 8 luglio 1977 n.485 che ha ratificato la Convenzione adottata a New York il 14 dicembre 1973, attinente alla protezione internazionale di cui godono
altri soggetti in condizioni consimili.
NOTE: IL PAMPLHET E' DISPONIBILE PRESSO L'AUTORE
Il paradosso e il mistero di un ricordo mondiale che dura immutato negli anni: quello di James Dean
di Luigi Favino
UN BINOMIO INSCINDIBILE TRA L'ATTORE E IL PILOTA.
E’ ormai un mito tutto quello che attiene a questo giovane, mancato anzitempo a 24 anni, e che ha emotivamente coinvolto più di una generazione
con soli tre film negli anni cinquanta, interpretati con straordinario ed innato talento. Anche quest'anno la sua leggenda ha avuto in regalo “Life”,
un bellissimo film presentato al Festival di Berlino 2015, del regista Anton Corbijn, e distribuito poi anche in Italia. Non si tratta di una
biografia vera e propria, ma della messa a fuoco di una “tranche de vie” dell’attore, quella che inizia all’indomani della proiezione del suo
primo film, “La Valle dell’Eden”. Il film di Corbijn, intelligentemente passa in rassegna quei pochi fatti più significativi a cavallo degli
anni 1954 e 1955: L’amicizia con Anna Maria Pierangeli, l’incontro con il fotografo Dennis Stock e la pubblicazione su Life delle foto più belle
ed espressive che questi gli aveva scattato con insistenza e determinazione. Ma soprattutto quella telefonata della Warner Bros che gli annunciava
la scrittura quale protagonista in “Gioventù bruciata”, il film di Nicholas Ray, che gli aprì le porte del successo definitivo. Era la realizzazione
dei sogni di Jimmy: infatti, il protagonista del film, altri non era che lui da ragazzo che studiava, uno che amava le auto sportive, che voleva
diventare un pilota per fare gare e circuiti, per correre con una propria auto. Proprio un sogno che con il film si era realizzato in quell’anno,
marzo 1955; con la vendita di due belle moto che possedeva, una Norton ed un’Harley, comprò una bellissima Speedster bianca della Porsche, dell’importatore
ufficiale nel suo lussuoso autosalone “Competition Motors”, che affacciava sulla North Vine Street, una delle più eleganti strade di Hollywood. Con
quell’oggetto del desiderio a disposizione, fu un anno molto intenso di gare per Dean che frequentava vari club sportivi che organizzavano raduni
sulla West Coast dove tutti correvano quando non erano spettatori di gare per piloti veri e propri, da Phil Hill a Dan Gurney a Richie Ginther che
giunsero addirittura in Formula Uno. Jimmy riusciva a destreggiarsi tra il lavoro cinematografico alla Warner Brothers ed i raduni sportivi con le gare,
correndo da una competizione all’altra per giungere a soddisfare in tal modo il piacere e il brivido che solo un circuito potevano dare a chi come lui,
aveva il desiderio di correre. Ecco perché se si dovesse tratteggiare più a fondo la figura di James Dean per qualche cenno biografico limitandolo
all’aspetto dell’artista più che a quello del pilota, significherebbe accontentarsi superficialmente di ciò che i Media hanno sempre descritto
tralasciando la parte più interessante e più realistica che lo vedeva interessato così profondamente al mondo delle corse e dei motori, “quasi”
un binomio inscindibile tra l’attore e il pilota. Durante le riprese dell’ultimo film “Il gigante” a Dean fu interdetto di correre e gareggiare;
era ormai nota la sua passione per le corse e in tal modo la produzione si era assicurata di arrivare a finire la lavorazione del film senza problemi,
quasi che qualcuno avesse avuto come un presentimento che riguardasse la salute e il fisico dell’attore. Del resto dai Media locali qualche notiziola
doveva pur essere arrivata agli orecchi dei registi e produttori sulla sua partecipazione vittoriosa a raduni sportivi con la piccola Speedster, come
quello di Palm Beach di fine marzo 1955 in cui vinse il primo premio dei principianti e arrivò al secondo posto nella gara successiva dietro auto da
competizione come le MG; o come quello del Memorial Day di Santa Barbara dello stesso anno, in cui Dean arrivò quarto malgrado la rottura di un pistone
nella classe fino a 1500 di cilindrata, risalendo dalla diciottesima posizione. La Porsche 356 Speedster, quella acquistata dall’attore, faceva parte
di una serie importata direttamente da Zuffenhausen per la clientela privata. Quando le esportazioni della piccola Porsche negli Usa ebbero un insperato
successo tra il pubblico sportivo, l’importatore Max Hofmann chiese con insistenza a Ferdy Porsche la costruzione di una sportiva più leggera e veloce
ma con carrozzeria aperta da affiancare ai coupé della linea 356. Poco dopo nel 1954 nacque la Speedster che con un motore prima di 1500cc e subito
dopo di 1600cc, che raccolse un immediato consenso tra i giovani e più tardi un successo di carattere internazionale con notevoli commesse. Ma cosa era
avvenuto prima di allora perché maturassero i tempi così favorevolmente per quest’ultima creazione della Porsche? Intanto è da premettere che subito dopo
la guerra ricominciarono alla Wolkswagen le vendite del Maggiolino che a causa del conflitto mondiale malgrado fosse stato prenotato da molti clienti
non poté vedere la luce prima degli anni 1949/50, con un successo che risaliva già a prima della guerra, oltre che per il favoleggiato uso in guerra
degli ufficiali tedeschi delle varie Kubelwagen della Kommandantur e della funzionalissima Schwimmwagen. Il successo pertanto non tardò a ripagare il
vecchio professore e i suoi figli dei tanti sacrifici sofferti con la vendita e con le conseguenti royalties sul marchio del Maggiolino. Ma addirittura
Porsche aveva rispolverato il vecchio progetto della sportiva in grado di girare l’Europa senza problemi al motore e senza quelle manutenzioni che
le auto sportive richiedono frequentemente. C’era poi da considerare i successi sportivi che dal 1950 al 1954 le piccole vetturette Porsche di 1100cc o 1300cc
avevano raggranellato su tutti i circuiti europei giungendo più volte prime, seconde e terze in ordine di arrivo e di classifica. Ma la cosa che riteniamo,
sia stata decisiva per i giovani e i meno giovani, fu il fatto determinante di togliere il motore centrale della Roadster posizionandolo a sbalzo nel vano
motore apposito della 356/02. Questo significava rendere la vettura sportiva adatta anche ai viaggi con bagagli sul retro dei sedili anteriori e per di più
con due bambini che potevano sedere sul sedile a panchina della 1600cc. Era nata così la Porsche per i lunghi viaggi che non conosceva impedimenti e
imprevisti dovuti a usura dei pezzi.
NOTE: L'ARTICOLO E' STATO PUBBLICATO SOLO IN ITALIA, SI VALUTANO RICHIESTE DI PUBBLICAZIONE SU STAMPA ESTERA.
Disapplicazione delle sentenze di condanna agli stranieri clandestini ed "inefficacia" della direttiva europea sui rimpatri
di Luigi Favino
Sul reato di cui all'art. 14, comma quinto ter, del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 (legge Bossi- Fini) riguardante la violazione dell'ordine di rimpatrio
impartito dal Questore, è intervenuta la Direttiva 2008/115 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, in data 16 dicembre 2008, che prevede norme e procedure
comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi, senza regolare permesso di soggiorno, che senza giustificato motivo si sono
trattenuti nel territorio dello Stato italiano. In questi ultimi anni la predetta disposizione è stata disapplicata dai giudici anche per una decisione della
Corte di giustizia di Strasburgo che il 28 aprile 2011 ha messo in evidenza il contrasto a livello europeo della previsione di una pena detentiva prevista per
il reato di immigrazione clandestina nella fase della permanenza del cittadino straniero nel territorio dello Stato italiano, a dispetto di un ordine di espulsione
a norma dell'art. 14 sopracitato. In sostanza l'Europa pur non facendo nulla di concreto per contenere direttamente il triste fenomeno dell'immigrazione clandestina,
da qualche anno contesta e contrasta i sistemi penali degli Stati membri che hanno adottato normative penali deterrenti con pene restrittive della libertà personale
volte ad arginare e far diminuire il fenomeno suddetto che ormai incide considerevolmente sui bilanci economici, soprattutto dell'Italia, oltre che sulla qualità
della vita dei cittadini italiani per l'affollamento umano, oltre il consentito e per ogni dove, dei cosiddetti "clandestini" nella nostra Penisola. D'altra parte
si deve riconoscere che come ha operato la sentenza che si commenta, si è voluta favorire la tutela dei diritti umani nei confronti di persone che hanno subito un
processo "ingiusto" (definito quasi sempre con la sospensione condizionale della pena), che tuttavia, ribaltato con una sentenza di assoluzione per inesistenza di
reato, (nullum crimen sine lege) ha cancellato come una più generale declaratorio di amnistia le migliaia di processi pendenti nei vari tribunali italiani, dei
cittadini clandestini che però nessuno ha provveduto materialmente a far rimpatriare nei rispettivi Paesi di origine. Salvo le ipotesi di cui all'art. 10 bis del
T.U. dell'immigrazione che prevede solo l'irrogazione di due ammende, per i clandestini, una per aver varcato la frontiera illegalmente, e l'altra per la permanenza
nel territorio dello Stato italiano, con la conseguenza che in caso di condanna i clandestini rimangono sul territorio, perchè la norma non è disapplicabile. Questa
circostanza assolutamente negativa per la situazione di confusione che crea in Paesi come l'Italia è in contrasto con la motivazione della sentenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea del 28 aprile 2011 che ha sottolineato ancora una volta lo spirito della direttiva del 2008, che era quello di mettere in condizione
lo straniero clandestino privo di documenti di poter preparare direttamente in Italia la procedura di rimpatrio, o di effettuare da parte delle autorità preposte,
l'allontanamento entro un certo termine fissato, di colui che non era stato in grado di tornare spontaneamente nel suo Paese. Di fronte a questa situazione che pone
in evidenza una posizione di stallo sia da parte dello straniero clandestino che non ottempera all'obbligo di tornare in patria, sia dello Stato che non riesce lo
stesso ad effettuare la procedura di rimpatrio, è necessario un più efficace intervento dell'Europa che predisponga mezzi idonei a non creare più situazioni di disagio
e di tragedia quali quelle che si sono verificate ultimamente nell'estate e fino all'ottobre 2013 intervenendo in via preventiva evitando gli sbarchi di clandestini
all'origine, dando in tal modo più ampio respiro al nostro Paese di smaltire le numerose pratiche arretrate di rimpatrio, mai eseguite, per l'aggiungersi di nuovi
ingressi quotidiani di stranieri. solo così potranno realizzarsi anche le finalità della stessa citata Direttiva europea, centrando la realizzazione degli obiettivi
perseguiti per fare pacificamente rimpatriare tutti coloro che clandestinamente e senza un lavoro regolarmente retribuito (v. la normativa del 2009 sulle badanti)
continuino a permanere negli Stati membri dell'Unione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di efficacia per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi
perseguiti. Alla luce di tutto questo sembra per ora non proprio urgente il rimaneggiamento della legge Bossi-Fini, come da più parti è stato sollecitato; ciò al fine
di evitare malintesi o implicite interpretazioni più benevole della norma che produrrebbero ulteriori confusioni ed illusioni in un momento critico come l'attuale.
E' sufficiente allo stato che i giudici possano disapplicare di fatto l'accusa e le sentenze di condanna per il reato di cui all'art. 14, comma quinto ter, del
D.L.vo n. 286/1998 contrarie allo spirito della direttiva 2008/115, senza alcuna conseguenza quanto all'esecuzione; rimarrebbe infatti invariata la misura dell'esplusione,
edulcorata dalla procedura concreta e mirata dell'effettivo rimpatrio dello straniero clandestino nel proprio Paese.
SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO PENALE DI
ROMA SEZ. I, 17 GENNAIO 2013, N.202 (C.C. 10 GENNAIO 2013)PRES. MAURO - EST. SCICCHITANO - P.M. X - IMP. BOTINARI Sicurezza pubblica; Stranieri; Ipotesi
di reato per permanenza illecita nel territorio dello Stato; Mera inottemperanza dell'ordine del questore; Configurabilità;
Disapplicazione della sentenza di condanna a pena detentiva; Assoluzione perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Deve essere disapplicata, in base a quanto chiaramente statuito dalla Corte di giustizia con la sentenza 28 aprile 2011 qualsiasi norma che, come quella di cui all'art. 14
comma quinto ter D.L.vo n.286/1998 preveda l'irrogazione di una pena detentiva nei confronti dello straniero sottoposto a procedura di rimpatrio in conseguenza della sua mera
inottemperanza ad un ordine di allontanamento dal territorio nazionale. L'accertata situazione di contrasto tra la citata norma incriminatrice e la successiva Direttiva
2008/115/CE (self executing nel nostro ordinamento, essendo decorso inutilmente il citato termine stabilito per il suo recepimento da parte dell'Italia), valutata alla
luce del principio generale stabilito dall'art. 2, secondo comma c.p., comporta l'assoluzione dell'imputato dal reato di permanenza illecita nel territorio dello Stato
(art. 14, comma 5 ter), perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato. (D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14).
NOTE: L’ARTICOLO E’ STATO PUBBLICATO SOLO IN ITALIA, SI VALUTANO RICHIESTE DI PUBBLICAZIONE SU STAMPA ESTERA.
La tutela della privacy a tutti i costi, non può violare i diritti umani
di Luigi Favino
Sul piano ermeneutico, tanto processuale che sostanziale, il tema del consenso giuridico è sempre stato uno dei più spinosi e complessi.
Non parliamo poi di quello a senso unico, quasi a tutti i costi, del consenso sui dati personali di cui alla Direttiva 95/46CE sulla privacy,
che affronta numerosi argomenti tecnici, tra cui quello della videosorveglianza pubblica e privata, con una logica inflessibile tutta nordica.
Ma una giusta, quanto attesa, interpretazione, più vicina alle persone è venuta proprio dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (nel 2014)
sul conflitto tra tutela della privacy e tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, di cui alle convenzioni internazionali e alle normativa di
diritto penale dei singoli Paesi. Quella stessa Corte che finalmente, nel mese di giugno 2015 ha promosso il piano del nostro Mario Draghi sullo
scudo anti-spread relativo all’acquisto dei Bond sovrani, dicendo che non viola le norme comunitarie e che è legittimo il cosiddetto OMT
(Outright monetary transactions) e cioè il piano illimitato di acquisti di titoli di Stato. Orbene, per tornare alla sentenza UE dello scorso anno
di cui è stata data notizia di recente, che in sintesi si annota, va precisato che i giudici europei hanno sgombrato il campo da lacci e lacciuoli,
in breve affermando il diritto dei cittadini all’autotutela per difendersi con videocamere da aggressioni a persone e beni al di là del consenso
di chi delinque. Sullo sfondo c’è l’odissea del solito cittadino preso di mira e danneggiato più volte, cominciata con il voler proteggere la propria
abitazione in una città della Repubblica Ceca con apparecchiature che, indirizzate sulla strada, fossero in grado di raccogliere immagini degli
sconosciuti che più volte gli avevano distrutto tutti i vetri delle finestre della casa negli anni lontani del 2007-2008. Una volta avvenuta
l’identificazione dei soggetti responsabili, è scattata in contemporanea per il malcapitato una denuncia nei suoi confronti da parte dell’ufficio
del Garante per le protezione dei dati personali, in quanto la tutela della privacy per la mancanza del consenso di coloro che avevano infranto con
i vetri anche la legge penale, ebbe a risultare più forte e cogente della tutela del diritto a difendersi per l’offeso dal reato. Inesorabile fu il
verdetto del Garante, perché dopo una non breve procedura, fu detto al danneggiato a chiare lettere che avrebbe dovuto esperire la procedura della
richiesta del consenso degli interessati per utilizzare quelle immagini, in applicazione proprio del dettato di quella implacabile Direttiva Europea.
Tuttavia, dopo qualche anno, il cittadino e il Garante (la burocrazia Ceca è simile a quella Italiana) si “ritrovarono” davanti alla Corte di Giustizia
Europea, per il rinvio cosiddetto pregiudiziale, perché questa chiarisse se la sanzione irrogata fosse da considerarsi proprio giusta nel senso giuridico
(e morale, diciamo noi): se cioè una volta per tutte, avesse proprio torto marcio quel cittadino offeso e perseguitato che, per aver registrato con la
videocamera immagini di sconosciuti passanti indifferenti, avrebbe dovuto chiedere il loro consenso nel momento e nell’ipotesi che questi fossero i veri
responsabili o comunque indiziati di reato nei suoi confronti. Nella sintesi, l’elaborata sentenza della Corte di Giustizia sulla Direttiva 95/46CE ha
finalmente dato ragione dopo oltre 7 anni di battaglie legali al cittadino ceco, stabilendo che anche quando le videocamere servono a difendere l’interesse
di chi le installa non ci sarebbe contrasto con la Direttiva in quanto questa consentirebbe, se interpretata intelligentemente, di valutare l’importanza del
loro interesse legittimo a proteggere i beni, la salute e la vita dei privati e delle loro famiglie. Una volta tanto non è valso l’assioma che la “privacy”
è usata soltanto a danno del cittadino; ma che soprattutto ha prevalso sulla astratta e rigida osservanza della tutela della privacy di chiunque a ogni costo
la tutela del diritto fondamentale dell’uomo alla difesa della sua persona e dei propri beni contro chi vuole offenderli. Tanto per non andare lontani, il
diritto a difendersi trova un immediato e quasi simile riscontro nel nostro ordinamento, nella causa di giustificazione della legittima difesa, ex articolo 52
codice penale. E’ il principio della libertà della condotta di chi reagisce ad una aggressione ingiusta a tutti i diritti personali e patrimoniali propri e
altrui, nel presupposto naturalmente di una proporzionalità tra i modi e i mezzi impiegati nelle rispettive azioni di aggressione e reazione. Principio
riconosciuto come tale dalla migliore dottrina e giurisprudenza.
Corte di Giustizia UE, Quarta Sezione, sentenza 11 dicembre 2014, causa C-212/13. Rinvio pregiudiziale – Direttiva 95/46/CE – Tutela delle persone
fisiche – Trattamento dei dati personali – Nozione di “esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico”.
L’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dev’essere interpretato nel senso che l’utilizzo di
un sistema di videocamera, che porta a una registrazione video delle persone immagazzinata in un dispositivo di registrazione continua quale un disco duro,
installato da una persona fisica sulla sua abitazione familiare per proteggere i beni, la salute e la vita dei proprietari dell’abitazione, sistema che sorveglia
parimenti lo spazio pubblico, non costituisce un trattamento dei dati effettuato per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico, ai
sensi di tale disposizione.
NOTE: L'ARTICOLO E' STATO PUBBLICATO SOLO IN ITALIA, SI VALUTANO RICHIESTE DI PUBBLICAZIONE SU STAMPA ESTERA.
La prevedibilità dell'incidente in un caso di guida imprudente della vittima e dell'investitore
di Luigi Favino
E' questo il tema di una recente sentenza della Cassazione della IV Sezione Penale, che ha annullato una precedente decisione della Corte d'Appello di Bari, disponendo un nuovo processo. In sintesi, si trattava di un omicidio colposo, conseguente ad un incidente stradale, in cui l'imputato, che viaggiava ad una velocità superiore a quella imposta, ha investito un veicolo che aveva effettuato un'improvvisa svolta a sinistra, attraversando repentinamente la carreggiata. Secondo la tesi accusatoria, fatta propria dal Tribunale di Foggia l'imputato, tale R.G. alla guida di un'auto, percorreva una strada statale alla velocità di più di 100 all'ora, sebbene vi fosse il limite di 90km/h. La vittima, Marino Anna, a bordo di un'Ape Piaggio a tre ruote, veniva nell'opposto senso di marcia ed invadeva l'altra corsia di marcia per svoltare in una stradina laterale sterrata. In quel momento sopraggiungeva l'auto, guidata dall'imputato causando con l'urto delle lesioni mortali per la donna. Il Tribunale aveva individuato vari profili di colpa a carico dell'imputato, riconducibili alla velocità eccessiva e comunque inadeguata in prossimità di un incrocio, ed anche di un'area di mercato; circostanze queste tali da costruire l'imputazione oggettiva e soggettiva del fatto, determinato per colpa specifica la morte della donna all'interno del veicolo Ape, con una condotta attiva che configurava il nesso di causalità materiale. La Corte di Appello, invece, nel riformare questa sentenza del Tribunale ha rilevato come la velocità eccessiva fosse l'unico addebito che poteva farsi all'imputato, perché il mercato non era in quel punto preciso e l'incrocio col viottolo di campagna non era affatto segnalato; mentre la donna, priva della patente di guida, non avrebbe avvertito la pericolosità della manovra che stava compiendo nel non dare la precedenza a chi sopraggiungeva nell'altro senso di marcia. Sulla base di questa diversa ricostruzione dei fatti, la Corte ha ritenuto il concorso di colpa della vittima nella produzione dell'evento nella misura del 60% diminuendo la pena all'automobilista. La Corte di Cassazione ha dovuto rispondere al quesito proposto nel ricorso dell'imputato, alla sentenza che abbiamo riportato in sintesi, e cioè: se l'automobilista avesse osservato il limite di velocità prescritto, l'evento si sarebbe verificato lo stesso? E' questo un interrogativo cui avrebbe dovuto rispondere la seconda sentenza, sostiene la Cassazione, in quanto questa aveva formulato una diversa valutazione dei fatti, e il Giudice "ERA TENUTO ALTRESI' AD ANALIZZARE I PROFILI CAUSALI GIA' DEDOTTI DALLA DIFESA IN QUELLA SEDE". La Corte (Pres. Battisti- Relatore Blaiotta) all'udienza pubblica di discussione ha annullato con rinvio al giudice civile, ritenendo carente la motivazione della sentenza della Corte di Appello, che non aveva chiarito se la condotta di guida della vittima fosse prevedibile e se le conseguenze determinatesi nel corso dell'incidente fossero prevedibili ed inevitabili. Proprio in relazione all'adeguamento della velocità
alle condizioni ambientali - ha sottolineato la Cassazione - è stata ripetutamente affermata la necessità di tener conto degli elementi di spazio e di tempo, e di valutare se l'imputato abbia avuto qualche possibilità di evitare il sinistro: la prevedibilità e la evitabilità vanno cioè valutate in concreto.
NOTE: L'ARTICOLO E' STATO PUBBLICATO SOLO IN ITALIA, SI VALUTANO RICHIESTE DI PUBBLICAZIONE SU STAMPA ESTERA.
Tentato omicidio con auto altrui: proprietario non ne risponde
di Luigi Favino
In un caso recente di guida dell'auto altrui, conclusosi con delle lesioni gravi procurate ad un pedone la Cassazione 1a Sezione
Penale - Pres. Fabbri - Rel. Chieffi - n. 22890) ha motivato che quando si fa un uso distorto dell'autovettura sicuramente non rientrante
nel concetto di circolazione stradale adoperandosi il veicolo in modo non conforme alla sua destinazione naturale, ma come strumento di
offesa per schiacciare una persona, a causa della condotta dolosa del conducente e della sua totale imprevedibilità, questo fatto illecito
non può essere attribuito oltre che al guidatore anche al proprietario del veicolo a titolo di corresponsabilità. Anche la Corte di Appello
di Caltanissetta era stata dello stesso avviso confermando la sentenza di condanna dell'imputato a 4 anni e 8 mesi di reclusione e ad una
provvisionale di duecentocinquantamila euro, ed aveva ritenuto estraneo il responsabile civile dell'auto "Fiat Panda". Con tale veicolo
il guidatore procedendo a retromarcia aveva investito tale Paolo N., scagliandolo violentemente contro un altro mezzo, un "Fiat Fiorino"
in sosta, schiacciandolo e procurandogli lesioni multiple che ne imponevano il ricovero urgente con prognosi riservata e pericolo di vita.
Su ricorso dell'imputato che sosteneva di non avere potuto andare avanti perché la strada era ostruita, e che non aveva voluto uccidere nessuno,
la Corte di Cassazione nella sua sentenza ha ritenuto invece che comunque doveva trattarsi di tentato omicidio volontario, sia per l'azione
posta in essere dal guidatore con la marcia indietro, con cui accettò l'evento morte come conseguenza altamente probabile della sua condotta,
non solo investendo la vittima ma continuando nella sua azione trascinandola e schiacciandola contro una struttura metallica al fine di metterne
in pericolo la vita. Tutto ciò, ovviamente, ha impedito alla Corte di prendere in considerazione la corresponsabilità del proprietario dell'auto,
superando il problema della prova che l'auto avesse circolato contro la volontà di questi: infatti, perché valga la presunzione della responsabilità
in solido del proprietario dell'auto con il guidatore, è necessario che risulti dagli atti "L'USO DEL VEICOLO COME MEZZO DI LOCOMOZIONE E NON
COME STRUMENTO DI OFFESA".
NOTE: L'ARTICOLO E' STATO PUBBLICATO SOLO IN ITALIA, SI VALUTANO RICHIESTE DI PUBBLICAZIONE SU STAMPA ESTERA.
Non basta vedere ma, contestare subito automobilista uso cellulare
di Luigi Favino
Parte della giurisprudenza del Giudice di Pace di Roma annulla la contestazione contravvenzionale dei VV.UU. tutte le volte che si sottrae all'obbligo della immediata contestazione. Rivive così l'esercizio del diritto di difesa dell'automobilista sancito dall'art. 23 penultimo comma della L. 689/1981 sulla depenalizzazione anche nel caso frequente dell'uso di un cellulare in auto privo di auricolare e di sistema a viva voce, in violazione dell'art. 178, co. 2, C.d.S. (V. per tutte G.d.P. di Roma - Savarese c./ Comune di Roma). Il legislatore ha voluto sanzionare la nullità del verbale per mancanza di logicità ed in evidente contraddizione con la verosimiglianza dei fatti, quando si è in presenza del dubbio sulla percezione sensoriale di chi ha "accertato" da molto lontano la violazione, in virtù del principio dell'onere della prova previsto dal citato art. 23, il quale stabilisce che, nel giudizio incardinato avanti al Giudice di Pace, a seguito dell'impugnazione del verbale di accertamento: "Il Giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente (v. tutta la giurisprudenza della Cassazione dalla sentenza della III^sezione civile 15/11/99, n. 3741 fino ad oggi). Il verbale di accertamento ha efficacia di prova fino a querela di falso solo in quei casi in cui il pubblico ufficiale attesta di avere percepito una realtà statica, di uno stato dei luoghi con oggetti fermi, ma non in tutti quegli altri casi di contestazione e percezione di oggetti in movimento. In tal caso si renderà necessaria una valutazione che tenga conto delle possibili smentite da parte dell'automobilista ai sensi dell'art. 23 della L. 689/81 sull'onere della prova in mancanza della contestazione immediata risalendo ai tabulati del telefonino in uso al guidatore, una volta identificato. Sarà questa una delle prove da cui desumere l'uso del telefonino in quel momento, e non in un altro, che dovrà essere indicato nel verbale con l'ora precisa della mancata contestazione della violazione da parte del verbalizzante. Quell'ora precisa potrà essere la base dell'accertamento, utile per la "discovery" per entrambe le parti della verità o meno del fatto addebitato, solo successivamente; quando il
cellulare è uscito di scena e neppure è sicuro che si potrà appurarne l'esistenza per colui che guidava l'auto, al di là di esserne il proprietario. Se invece per avventura si fosse proceduto alla contestazione immediata, ecco che per prima cosa si chiarisce chi sia al volante e di conseguenza l'autore dell'ultima telefonata, quella che è stata vista dall'agente che ha fermato l'auto, pochi metri prima, soprattutto se fosse solo ed il telefonino fosse lì visibile sul sedile. In questo caso ci sarebbe stato un controllo obbiettivo ed immediato in grado di superare la labile percezione dei sensi, cui avrebbe seguito la precisa contestazione della contravvenzione, alla presenza di elementi inoppugnabili, proprio perché la contestazione immediata è la regola e non l'eccezione. Per cui, di fronte all'ingiusto addebito di un fatto a chi non lo ha commesso al di là di ogni ragionevole dubbio, è cosa saggia l'applicazione dell'art. 23 penultimo comma della legge "sulla depenalizzazione" (cosiddetta per semplicità di esposizione), che pone a carico della pubblica amministrazione l'onere di provare ogni incertezza sulla sussistenza delle contravvenzioni.
NOTE: L'ARTICOLO E' STATO PUBBLICATO SOLO IN ITALIA, SI VALUTANO RICHIESTE DI PUBBLICAZIONE SU STAMPA ESTERA.
I ricorsi al Giudice di pace per le multe stradali
di Luigi Favino
L'OBBLIGO DELLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DEL VERBALE DI VIOLAZIONE E SUA IMPORTANZA NEL SISTEMA DELLA PATENTE A PUNTI ALL' INDOMANI DELLA DIRETTIVA
MARONI 21 AGOSTO 2009. La contestazione immediata della violazione ai sensi dell'art.201 C.d.S. è un obbligo posto dal Legislatore a carico
degli agenti incaricati del controllo e del pattugliamento delle strade che non conosce deroghe, se non in alcuni casi specifici elencati nel comma 1 bis
della stessa norma, e nell'art. 384 del Regolamento del Codice della Strada recante la rubrica “casi di impossibilità della contestazione immediata”.
La ragione di tale obbligo risiede nella necessità di certezza e speditezza del procedimento di identificazione e notifica al trasgressore del verbale,
con risparmio di mezzi e spese, mentre le ragioni della deroga a tale principio generale sono da ricercare nella presenza di altri interessi come la sicurezza,
naturalmente preminenti, il cui doveroso rispetto si impone anche a scapito dei primi, o nell'oggettiva impossibilità di rispettare tale principio. Nella
prassi concreta di tutti i giorni, tuttavia, tale obbligo, costituente la regola generale, si tramuta in eccezione, essendo sempre più frequente la
notificazione dei verbali di contravvenzione al domicilio del proprietario del veicolo, così come risultante dai pubblici registri, con la conseguenza
non indifferente dell'azionamento di ulteriori procedure, nonché, a seguito dell'introduzione della patente a punti, di obblighi per il cittadino. Oltre
ai pregi di maggiore celerità e speditezza, già accennati la contestazione immediata consente infatti l'identificazione dell'autore della violazione in
uno stato di quasi flagranza, con possibilità di errore ridotta, ed in caso di sanzione aggiuntiva costituente decurtazione dei punti della patente, offre
la possibilità di far partire l'accertamento necessario nei confronti del soggetto responsabile della violazione, senza ulteriori passaggi. La notificazione
del verbale in caso di mancata contestazione immediata, previsto dall'art. 201 C.d.S., deve perfezionarsi al domicilio del proprietario del veicolo entro
il termine tassativo di centocinquanta giorni dall'accertamento della violazione, a pena di nullità del verbale e dell'intero procedimento sanzionatorio.
A parte i ritardi di consegna e le imprecisioni del verbale che inficiano la validità dell'atto e che, in ultima analisi, vanno a vantaggio del destinatario
della contravvenzione, in alcuni casi il termine di cui all'Art. 201 C.d.S. non viene rispettato dall'Ufficio o dall'Organo accertatore, e, tuttavia, l'atto
notificato in apparente ritardo conserva la sua validità. Ciò avviene sempre e soltanto in casi di mancata contestazione immediata, ed in particolare nei
casi in cui, per le modalità di rilevazione della violazione con mezzi particolari (autovelox), il momento dell'accertamento non coincide con il momento
della violazione, ma è differito rispetto ad esso, sotto il profilo temporale e spaziale, realizzandosi al momento dello sviluppo della pellicola all'interno
di un Comando o di un Ufficio, qualche mese dopo. Il trasgressore che si vedesse notificare un verbale di violazione al codice della strada, rilevata
attraverso un sistema elettronico, oltre il suddetto termine, e che decidesse di eccepire la tardività della notifica nelle opportune sedi, vedrebbe rigettata
la propria eccezione sulla base di tale discutibile principio della distinzione tra “momento della violazione” e “momento dell'accertamento”, da cui decorre
il termine dell'art. 201 C.d.S. L'interpretazione parziale della norma è evidente, se si pensa che c'è quasi sempre una pattuglia che installa l'autovelox e
redige il verbale sul luogo della violazione, indicando i motivi per cui non è stato possibile fermare il veicolo, svolgendo pertanto un'attività di controllo
delle strade e, a rigor di logica di accertamento anche della violazione, potendosi benissimo posizionare in posizione defilata rispetto all'apparecchio e
contestare immediatamente la violazione, essendo avvertiti per tempo dallo stesso sistema elettronico. Sembrerebbe quasi che, nella necessità di “fare cassa”,
la scelta migliore non sia quella di fermare il trasgressore perdendo tempo a identificare, contestare, o “conciliare”, ma sia invece quella di raccogliere
elementi da valutare ed “accertare” in un secondo momento, in un modo impersonale ed asettico rispetto al fatto e al momento storico, anche a distanza di mesi
dalla contravvenzione, con possibile violazione della privacy con l'invio delle foto a corredo del verbale, specie se trattato da personale non appartenente
alle forze dell'ordine preposte al controllo. Si pensi a quanto verificatosi in più Comuni con gli abusi nella gestione delle apparecchiature degli “Autovelox”.
A TALE PROPOSITO L'IMPORTANTE DIRETTIVA MARONI 21 AGOSTO 2009 HA INIZIATO QUELLA NECESSARIA RIFORMA DELLA NORMATIVA SULLE APPARECCHIATURE DEGLI AUTOVELOX AFFIDANDO
L'ESCLUSIVA GESTIONE E TRATTAMENTO DELLE APPARECCHIATURE “AUTOVELOX” AL SOLO PERSONALE DEGLI ORGANI DI POLIZIA. In tal modo vi sarà una maggiore connessione per
la soluzione dei problemi relativi alla sicurezza stradale da una parte e dall'altra con la gestione dei dati più sensibili con la tutela della privacy nel
trattamento di foto e riprese video. Il completamento della normativa dovrà avvenire con l'obbligo della contestazione immediata di tutte le contravvenzioni
effettuate con apparecchiature elettroniche ed in particolare con il rafforzamento delle pattuglie della polizia laddove sarà più necessario. Altri problemi
scaturiscono da una parte dalla mancata contestazione immediata della violazione, di cui si è detto sopra, e dall'altra soprattutto dalla individuazione del
soggetto a cui applicare la decurtazione dei punti della patente a norma dell'art. 126 bis del Codice della Strada. Se infatti non si identifica per il tramite
della contestazione immediata l'effettiva identità del trasgressore, e dunque si procede per la notifica al domicilio del proprietario del veicolo, del verbale
di violazione, questi sarà obbligato, a distanza di mesi dal fatto, a dichiarare chi fosse alla guida del suo mezzo, rischiando, in caso di tardiva od omessa
dichiarazione, di vedersi recapitare una ulteriore sanzione(fissata oggi in un minimo di € 250/00), e cioè molto probabilmente a una somma di denaro superiore
a quella della contravvenzione contenente la sanzione aggiuntiva della decurtazione dei punti. Ciò anche nell'ipotesi che il proprietario del veicolo, ricevuto
notificato il verbale di violazione, lo abbia pagato nei termini, ma abbia ritenuto superfluo (perché lui stesso autore della violazione) inviare tale dichiarazione,
ovvero se ne sia dimenticato, o non se ne sia accorto.
INIQUE LE SANZIONI A CARICO DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO PER L'ESISTENZA DI UN VUOTO NORMATIVO PRIMA DELLA MODIFICA DELL'ART. 126 BIS C.D.S.
Nel periodo immediatamente successivo alla introduzione della patente a punti, in mancanza di contestazione immediata, e dunque di identificazione del trasgressore,
l'Ufficio accertatore procedeva ingiustamente alla decurtazione dei punti della patente del proprietario del veicolo, potendo questi indicare, ai fini di evitare
la sanzione aggiuntiva, il nominativo del conducente al momento della violazione. A carico del proprietario che ometteva di indicare il nominativo del trasgressore
veniva poi applicata la sanzione di cui all'art. 180 co. 8 C.d.S., originariamente preveduta soltanto per le persone giuridiche proprietarie di autoveicoli, che
agevolmente erano in grado di eludere la decurtazione dei punti, e a cui rinviava l'art. 126 bis co. 2 C.d.S. Un'azienda, infatti, dotata di parco macchine o
comunque di una serie di veicoli, non essendo obbligata a tenere un registro movimenti dei mezzi, cosa che comunque, anche se esistente, avrebbe una semplice
rilevanza interna e non servirebbe allo scopo, mai avrebbe potuto indicare con certezza quale impiegato fosse alla guida di quel dato mezzo, in quel dato giorno,
e cioè a distanza di mesi dal fatto, godendo di una sorta di “impunità”, per la decurtazione dei punti e venendo per questo motivo,”tassata” attraverso il rinvio
alla sanzione di cui all'Art.180 co. 8 cds. Al proprietario persona fisica, invece, erano decurtati i punti a meno che non indicasse il nominativo di un altro
soggetto, e se ometteva di farlo senza giustificato motivo, subiva la sanzione di cui all'Art.180, ciò utilizzando un'interpretazione quanto meno estensiva della
norma, posto che dal combinato disposto dei due articoli non era dato evincersi un obbligo a suo carico di fornire la dichiarazione richiesta. A parte la difficoltà
di ricordare con esattezza a distanza di tre o quattro mesi chi fosse alla guida del veicolo in una determinata e precisa circostanza, anche nel caso di elevata
probabilità di coincidenza tra proprietario e trasgressore, l'obbligo di rendere una dichiarazione del genere per non subire la decurtazione dei punti della patente,
e' apparso subito in grado di limitare l'autonomia del cittadino, costretto a denunciare se stesso od altri, pur essendo nei termini di esperire ricorso avverso la
sanzione amministrativa. La Corte Costituzionale, intervenuta sul punto con la sentenza n.27 del 2005, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 126 bis, co. 2 C.d.S.
nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti, quando ometta di comunicare le generalità del conducente, fin qui accogliendo
le eccezioni sollevate sul punto e stabilendo la necessità dell'assoluta certezza dell'identificazione personale per l'immediato avvio del procedimento di decurtazione,
dovendosi esaurire ogni procedura (ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace) di impugnazione, e naturalmente di pagamento nei termini, prima di poter procedere alla
decurtazione dei punti. La Corte, inoltre, nella stessa sentenza ha anche lanciato lo sguardo sul problema relativo all'esistenza o meno di un obbligo. giuridico a
carico del proprietario del veicolo in relazione alla dichiarazione richiesta dall'Art. 126 bis, C.d.S. consigliando solo di estendere la sanzione di cui all'Art.
180 co. 8, C.d.S. anche alla persona fisica che omettesse di comunicare le generalità del trasgressore. Tale “consiglio” ha moltiplicato, poiché erroneamente
interpretato, l'invio di sanzioni per violazione dell'Art. 126 bis co. 2 C.d.S. (omessa dichiarazione) ai cittadini, ma ancora in assenza di una specifica norma
che autorizzasse tale comportamento. La Corte Costituzionale, infatti, si è limitata a consigliare di estendere detta sanzione alla persona fisica, dando di fatto
per inesistente, allo stato, una norma che la prevedesse se non soltanto a carico della persona giuridica proprietaria di veicoli. LA CORTE, DUNQUE, ATTRAVERSO
LA SUA SENTENZA HA RILEVATO L'ESISTENZA DI UN LUNGO VUOTO LEGISLATIVO, poiché la norma mancante non è stata creata con la sentenza, che non poteva sostituirsi
al Legislatore. Il Governo ha provveduto a colmare questa lacuna, dopo un primo decreto, non convertito, soltanto con il D.L. 262 del 3 ottobre 2006, convertito
in Legge n.286/2006, CON IL QUALE IL TESTO DELL'ART. 126 bis E' STATO DEFINITIVAMENTE MODIFICATO, OBBLIGANDO IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO, SIA ESSO PERSONA FISICA O
GIURIDICA, CHE OMETTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO DI FORNIRE I DATI DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO AL MOMENTO DELLA COMMESSA VIOLAZIONE, È PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA
DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO. (ridotta rispetto alla sanzione di cui all'Art. 180 co. 8 C.d.S.). PERTANTO, ALMENO FINO ALLA DATA DEL 3/10/06, NESSUNA NORMA
OBBLIGAVA IL CITTADINO PROPRIETARIO DEL VEICOLO, A FORNIRE I DATI DEL TRASGRESSORE, SE NON IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DÌ LEGALITA' E DELLA RISERVA DI LEGGE.
NOTE: L'ARTICOLO E' STATO PUBBLICATO SOLO IN ITALIA, SI VALUTANO RICHIESTE DI PUBBLICAZIONE SU STAMPA ESTERA.
Sant'Alfonso protettore di avvocati e giuristi
di Luigi Favino
PROFESSIONE FORENSE: "DICHIARAZIONE SU REGOLE MORALI AVVOCATO".
Oltre che dei confessori, Sant’Alfonso fu proclamato protettore di avvocati e giuristi già dal 1871, quando era già stato canonizzato e nominato Dottore della Chiesa. Era nato a Marinella, in provincia di Napoli, nel 1696, in una nobile famiglia che lo avviò, dopo gli studi classici, a quelli giuridici di diritto civile ed ecclesiastico, divenendo avvocato giovanissimo. Le cronache a questo riguardo, narrano che avesse appena diciotto anni quando conseguì il titolo. Evidentemente, la professione di Avvocato nel Regno di Napoli era regolata più semplicemente rispetto al nostro sistema, un po’ sul tipo di quello invalso in gran Bretagna, con la distinzione tra il “Solicitor” e il “Barrister”...Avvenne così che il giovane Alfonso, sia pure aiutato all'inizio dai parenti che gli procurarono i primi clienti, esercitasse la professione forense vestendo la toga in molti processi penali dell'epoca, ed ottenesse notevoli successi che lo posero in rilievo tra i migliori avvocati di quegli anni. Un suo primo biografo tra gli avvocati, scrisse di lui queste poche righe significative: "tutto lo rendeva singolare: vastità di talento, chiarezza di mente e precisione nel dire, somma onestà e sommo orrore dei cavilli. Non intraprendeva una causa, se non giusta. Ed aveva un tal dominio dei cuori che ammaliava i giudici e rendeva muti gli avversavi". Dirittura morale e competenza professionale, formavano in lui un tutto inscindibile, al punto di mettere per iscritto una sorta di "dichiarazione sulle regole morali dell'avvocato", che portava con sé, e nella quale aveva sintetizzato in un bell'italiano del settecento, i punti più delicati della professione forense, ai quali si era sempre attenuto scrupolosamente. Eccone il testo:
1) Non bisogna mai accettare cause ingiuste, perché sono perniciose per la coscienza e pel decoro.
2) Non si deve difendere una causa con mezzi illeciti e ingiusti.
3) Non si deve aggravare il cliente di spese indoverose altrimenti resta all'avvocato l'obbligo di restituzione.
4) Le cause dei clienti si devono trattare con quell'impegno con cui si trattano le cause proprie.
5) E' necessario lo studio dei processi per dedurne gli argomenti validi alla difesa della causa.
6) La dilazione e la trascuratezza degli avvocati spesso dannifica i clienti, e si devono rifare i danni, altrimenti si pecca contro la giustizia.
7) L'avvocato deve implorare a Dio l'aiuto nella difesa, perché Iddio è il primo protettore della giustizia.
8) Non è lodevole un avvocato che accetta molte cause superiori ai suoi talenti, alle sue forze e al suo tempo, che spesso gli mancherà per prepararsi alla difesa.
9) La giustizia e la onestà non devono mai separarsi dagli avvocati cattolici, anzi si devono sempre custodire come la pupilla degli occhi.
10) Un avvocato che perde una causa per sua negligenza si carica dell'obbligazione di rifare tutti i danni al suo cliente.
11) Nel difendere le cause bisogna essere veridico, sincero, rispettoso e ragionato.
12) Finalmente i requisiti di un avvocato sono: la scienza, la diligenza, la verità, la fedeltà e la giustizia.
Malgrado l'impegno profuso e l'entusiasmo nell'esercitare l'avvocatura, Alfonso nel 1723, dopo una non breve pausa di riflessione, vincendo anche l'opposizione del padre, decise di abbandonare la professione e di farsi seminarista nel Clero diocesano. In tre anni, divenuto sacerdote, profuse in questa nuova vocazione lo stesso amore ed entusiasmo espressi nell'avvocatura: in lui la fede e lo zelo cristiani erano così abbondanti che tutti i giorni nel tempo libero si prendeva cura dei senzatetto, unendo la dottrina alla carità, aiutando i più disgraziati di loro nelle periferie di Napoli, finché fondò le cosiddette "Cappelle Serotine", veri e propri centri di preghiera e di ascolto, oltre che di istruzione, riuscendo a togliere dalla strada e dal delitto, molti di questi giovani, alcuni dei quali abbandonati dalle famiglie in tenera età nella Napoli del Settecento. Quando i centri raggiunsero un numero considerevole, Alfonso comprese che era il momento di fondare una Congregazione che li riunisse tutti, al fine di insegnare il Vangelo a tutti i poveri e ai ragazzi nel nome del SS. Redentore. Un'idea che probabilmente inseguiva da anni e che finalmente poté realizzare, consentendogli di formare anche giovani sacerdoti come lui stesso, servendosi anche della sua esperienza di avvocato, per superare le immaginabili difficoltà burocratiche di quegli anni. Da allora quei sacerdoti si chiamano Redentoristi e svolgono da diversi decenni la loro missione nel mondo. I Redentoristi sono conosciuti anche come "Gesuiti di Campagna" perché si rivolgevano alle persone più umili delle periferie e delle campagne pur di annunziare a tutti la Buona Novella. Malgrado fosse occupato tutto il giorno, Alfonso trovò il tempo di scrivere oltre cento volumi di carattere religioso, teologico e perfino un cantico natalizio che lo rese famoso
in tutto il mondo: "Tu scendi dalle stelle" tra le tante pagine musicali da lui create grazie alla cultura classica e lirica acquisita in gioventù. Il migliore contributo offerto da Alfonso alla Chiesa è la "Teologia Morale", un'opera scritta con l'esperienza di sacerdote e poi di vescovo nella quotidianità dei rapporti con i suoi fedeli e con Cristo: "un rapporto di amore intenso e irresistibile - hanno
scritto di lui i biografi - dei discepoli con il loro Maestro, dell'uomo debole e peccatore con il suo Redentore e Salvatore Gesù Cristo". Al contrario dell'uomo medio contemporaneo che non parla più di peccato, perché ne ha perso la percezione, Sant'Alfonso usa spesso questo termine, perché sa bene che proprio il peccato è alla radice del malessere profondo dell'uomo che è causa del suo distacco da Dio per
l'assurda pretesa di fare a meno di lui, escludendolo dalla propria vita. Egli invece ha sempre insegnato a rivolgersi a Dio con immenso affetto e fiducia convertendo migliaia di anime e vincendo il male con la forza del bene, e l'odio con l'amore. Nella stessa ottica vanno altri libri da lui scritti come quello su "La Via Crucis", le "Riflessioni e affetti sulla Passione di Gesù Cristo" e "Le Glorie di Maria".
Anche da Vescovo non si stancò mai di portare anime a Dio; la consacrazione al titolo avvenne nel 1762 nella diocesi di S. Agata dei Goti. Al momento della nomina S. Alfonso avrebbe voluto rifiutare quell'incarico, che poi accettò ricoprendolo per oltre dodici anni, sapendo - come scrisse un altro suo biografo - porre la riflessione teologica al servizio della grandezza e della dignità della persona,
della coscienza morale e della misericordia evangelica.
NOTE: L'ARTICOLO E' STATO PUBBLICATO SOLO IN ITALIA, SI VALUTANO RICHIESTE DI PUBBLICAZIONE SU STAMPA ESTERA.
La pretesa disumanizzazione del modello nell'opera d'arte
di Luigi Favino
Sommario: 1) Il consenso del modello della riproduzione dell'opera d'arte. 2) Il consenso non equivale ad abdicazione. 3) La posizione reale del modello. 4) sulla qualifica di opera d'arte. 5) su altre possibili distinzioni. 6) Il caso del catalogo delle opere artistiche. 7) Conclusione.
IL CONSENSO DEL MODELLO DELLA RIPRODUZIONE DELL'OPERA D'ARTE. Nella delicata e complessa materia della disponibilità dell’opera e delle facoltà spettanti ai singoli partecipi vige un principio che può senz’altro considerarsi scontato: la posizione non può essere riguardata da un angolo visuale unilaterale dei rapporti ma considerata invece sulla base di un equilibrato contemperamento della posizione di tutti i soggetti interessati; principio questo che si inquadra nella disciplina generale della materia de qua. E’ dunque essenziale e preliminare far costante riferimento alla volontà dei soggetti e quindi alla portata del consenso espresso dai medesimi. Ma quale è la reale portata di tale consenso e soprattutto entro quali limiti ed a quali condizioni esso è operante? Come è noto la Corte costituzione ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità dell'art.161 della L. 22 aprile 1941 n.633 (sul diritto d'autore) e dell'art.700 cod. civ. in relazione all'art.10 cod. civ. nonchè degli artt. 96, 97, 156, 168 della predetta legge sollevate in riferimento all'art.21 della Costituzione; e precedentemente aveva ritenuto non fondata in riferimento all'art.3 della Costituzione la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 87, 92 della medesima legge concernenti la disciplina speciale dei diritti relativi alla fotografia ed in particolare la mancata concessione agli autori della protezione del diritto morale di cui all'art.20 della legge citata. E' peraltro da ricordare che secondo un magistrato di merito, il ritratto di un soggetto eseguito da un artista può essere liberamente esposto "anche ai fini commerciali" da parte di chi ha conseguito la disponibilità dell'opera: tale principio è stato pienamente condiviso nella nota posta a corredo della sentenza medesima. Pur ammirando l'acutezza delle considerazioni esposte e dal giudicante e dell'annotatore mi sembra di dover esprimere il più netto dissenso. Il pretore parte dal presupposto che il consenso prestato dal soggetto ritratto durante il processo creativo dell'opera implicherebbe anche adesione alla esposizione ed alla pubblicità anche ai fini commerciali; e ciò in quanto "l'elemento riproduzione di immagine passa in seconda linea per cedere a quella assorbente della interpretazione che dell'immagine stessa l'artista è chiamato a dare". Questa concensione viene ripresa e maggiormente accentuata dal Santoro, il quale esprime l'avviso che l'immagine della persona costituirebbe lo "strumento", il "mezzo" posto liberamente a disposizione dell'artista in funzione della sua libertà creativa; il che farebbe venir meno i diritti presidiati
dall'art.10 cod. civ. e dall'art.96 della legge sul diritto d'autore. In altri termini la tutela dell'immagine e quindi del ritratto cesserebbe dal momento in cui essa viene posta al servizio di altro soggetto come strumento dell'attività e dell'opera creativa di questo.
(Dalla rivista "Archivio Civile" (già Archivio della responsabilità civile). Rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione, Direttore Alfonso Alibrandi. Anno XXI - N. 7-8 Luglio-Agosto 1978).
NOTE: L'ARTICOLO COMPLETO E' DISPONIBILE PRESSO L'AUTORE.
Roma Capitale al tempo del Belli
di Luigi Favino
Difficile immaginare la grandezza di Roma capitale dello Stato Pontificio ottocentesco, senza la lettura dei Sonetti di Giuseppe Gioachino Belli. Di quella Roma, Gioachino è stato l’intelligente narratore “inventandosi”, come si dice oggi, un’opera gigantesca; come Orazio che diceva dei suoi versi “Exegi monumentum aere perennius”[1], altrettanto egli scriveva che il suo “Commedione” doveva intendersi come un monumento alla plebe romana, della quale metteva in luce spirito, costumi e modi di vivere; di questo popolo “sui generis”, tanto diverso quanto unico perché discendente dai “cives romanus”. Nato a Roma il 7 settembre 1791 e qui morto nel 1863 il Belli, nel ventennio a partire dal 1815, ebbe una parentesi di vita agiata che gli permise di dedicarsi alla poesia dialettale romanesca, mostrando subito una ricca vena compositiva nell’arte del sonetto e scrivendone migliaia, oltre un canzoniere in lingua italiana. In quel periodo il poeta abitava in un appartamento elegante al piano nobile di Palazzo Poli, al centro di Roma, nella casa del conte Giulio Pichi di cui aveva sposato la ricca vedova, Maria Conti, la quale si era innamorata perdutamente di lui. Dal palazzo che ora non c’è più, perché l’area servì per fare posto alla Via del Tritone, Belli osservava i personaggi e gli artigiani che gravitavano nelle vie da cui in pochi minuti si raggiungeva Fontana di Trevi, Piazza di Spagna e il Corso, e attraverso molti
vicoli persino il Vaticano; in poche parole il cuore della vita pubblica ed ecclesiastica, che inseriva di volta in volta nei suoi sonetti. La cronaca nera del tempo, pur senza l’ausilio della stampa, faceva registrare giornalmente grassazioni, violenze e fatti di sangue con tutti gli “ammazzamenti” della delinquenza. Spesso le guardie erano sotto tiro e fatte segno da malviventi anche con episodi di agguati e violenze, non solo in periferia; ma anche nelle vie centrali residenziali poco frequentate, come il Belli ci racconta in questo sonetto:
Stamio immezz’a na macchia Caterina
E non in d’una città drent’a le mura.
T’abbasti a dì c’a San Bonaventura
Me ciassartorno a me, jer’a mattina.
Pavura io? De che? Pe’ cristallina!
Un omo solo m’ha da fa’ pavura?
M’aveva da pija’ senza muntura
Lui, e poi ne volevo na’ duzzina.
Quanno me venne p’envesti’, me venne,
Io pe’ la rabbia me ce fece rosso:
Ma cosa voi! Non me potei difenne.
E archibuscio, e sciàbbola e bainetta…
Co sta battajeria c’avemo addosso,
Come avevo da fa’, si’ benedetta!
Tra l’altro S. Bonaventura non era lontano dal centro, perché la relativa chiesetta sta sulla cima del colle di fronte a quella del Palatino, e la stradetta sterrata in salita sopra S. Francesca Romana è sempre stata isolata tra le rovine del Foro Romano e si prestava a rapine ed agguati. Fatti del genere accadevano malgrado le guardie fossero comunque numerose (la Roma papale aveva un vero e proprio contingente militare di stanza, dalla Guardia civica a quella Palatina) e i servizi di picchetto fossero frequenti e severi. Così come quando in un altro sonetto, il Belli descrive il cocchiere di un ambasciatore alle prese con un drappello della Guardia Palatina che aveva fermato la carrozza con a bordo il suo padrone, per un controllo:
Largo, sor militare cacarella;
U primo er passo, alò, sor taja-calli:
Che sti nostri colori neri e gialli
Nun conoschen’un corno sentinella.
Sò Casa-d’Austria, sò, dio serenella!
Dich’eh, badat’a voi, brutti vassalli,
Perch’io co’ sta carrozza e sti cavalli
Pozzo entrà, casomài, puro in Cappella.
E doman’a mattina, sor dottore,
Ciariparlàmo poi co Su Eccellenza
Davant’a Monsignor Governatore.
Guardate lì si che quaja-lommarda
De soverchià er cucchier d’una Potenza
E nun portà rispetto a la cuccarda!
Con poche parole il poeta pennella “l’argot” del cocchiere che con la carrozza “imbandierata” si sente qualcuno, al servizio “di una Potenza”, quasi un “europeo”... prima ancora che l’Europa fosse, con un lasciapassare che gli permette di portare il Diplomatico fin dentro il Vaticano, addirittura nella Cappella dove si svolgeva la funzione del giorno. La satira che induce all’umorismo senza essere pesante, è sempre presente nel Belli, anche quando si occupa dell’ambiente ecclesiastico, che è al tempo stesso internazionale, nella Roma di allora; tra quelle persone, in quelle chiese, Belli sa muoversi benissimo, perché da sempre è stato a contatto con monsignori, cardinali e legati pontifici, con tutto quel mondo che era di casa in Vaticano, ma che non disdegnava di essere presente nei salotti più importanti
della Capitale. A tal riguardo uno dei più significativi sonetti è quello del “Miserere”, che trae spunto dal salmo più noto cantato col rito Gregoriano nella Settimana Santa: “Miserere mei, Deus, secondum magnam misericordiam tuam”.
Tutti l’Ingresi de Piazza de Spagna
Non hanno antro che dì si che piacere
È de sentì a San Pietro er miserere
Che gnisun istrumento l’accompagna.
Defatti, caro, in me la Gran Bertagna
E in nell’antre cappelle furistiere
Chi sa dì com’a Roma in ste tre sere
Miserere mei Deo sicunnum magna?
Oggi sur magna ce so stati un’ora
E cantata accusì, sangue dell’ùa,
Quer magna è una parola che innamora.
Prima l’ha detta un musico, poi dua,
Poi tre, poi quattro; e tutt’er coro allora
J’ha dato giù: misericordiam tua.
Giuseppe Gioachino, quando sposò la più matura Mariuccia che aveva 38 anni, era un bell’uomo, così come appare nel ritratto del De Sanctis (conservato al Museo di Roma a Palazzo Braschi) che sembra somigliare in qualche modo all’indimenticabile Paolo Stoppa da giovane. Alla moglie affettuosamente dedica nel 1821 una significativa terzina:
Pietà le pose la mia storia in core
appresso alla pietà venne amicizia
e all’amicizia poi successe amore.
Dal matrimonio nacque il figlio Ciro, che entrambi i coniugi d’accordo, affidarono per la sua migliore educazione al Collegio Pio di Perugia, uno di quelli più esclusivi del tempo. Quello fu il periodo anche più spensierato per il Belli, fatto di viaggi: nelle Marche (la famiglia proveniva da Recanati), in Umbria e a Milano, dove conobbe i sonetti in vernacolo del Porta. Mentre a Roma proseguiva la sua attività di poeta raggiungendo una certa notorietà nei circoli romani e all’Accademia Tiberina. Rileggiamo per concludere questo breve ricordo del Belli di quel periodo, il bellissimo sonetto “Er giorno der giudizio” (ispirato al Michelangelo della Cappella Sistina) dove l’arte poetica raggiunge altissimi toni:
Quattro angioloni co le tromme in bocca
Se metteranno uno pe’ cantone
A sonà: poi co’ tanto de vocione
Cominceranno a dì: «Fora a chi tocca!»
Allora vierà su na’ filastrocca
De schertri da la terra a pecorone,
Pe ripija figura de persone,
Come purcini attorno de la biocca.
E sta biocca sarà Dio benedetto,
Che ne farà du’ parte, bianca e nera;
Una pe annà in cantina, una sur tetto.
All’urtimo uscirà na’ sonajera
D’angioli, e, come si s’annasse a letto,
Smorzeranno li lumi, e bona sera!
[1] La solenne orgogliosa dichiarazione di gloria eterna è posta alla fine della raccolta dei primi tre libri pubblicati nel 23. La dichiarazione è sostenuta dalle remiscenze di due grandi lirici greci, Simonide e Pindaro, di cui sono riecheggiati alcuni versi. Era comunque d’uso che nell’ultimo componimento di una raccolta lirica il poeta apponesse una sphragís (sigillo), col quale dichiarava il suo nome e forniva indicazioni e notizie su di sé.
NOTE: L'ARTICOLO E' STATO PUBBLICATO SOLO IN ITALIA, SI VALUTANO RICHIESTE DI PUBBLICAZIONE SU STAMPA ESTERA.
Informazioni Generali
di Luigi Favino
Il sito web "www.luigifavino.it" non costituisce testata giornalistica e la diffusione di eventuale materiale interno al sito non ha comunque carattere periodico ed è condizionata alla disponibilità del materiale stesso.
I testi, le informazioni e gli altri dati pubblicati in questo sito nonché eventuali link presenti sul web hanno esclusivamente scopo informativo e non assumono alcun carattere di ufficialità.
Pertanto Luigi Favino non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni di qualsiasi tipo e per qualunque tipo di danno diretto, indiretto o accidentale derivante dalla lettura o dall'impiego delle informazioni pubblicate, o di qualsiasi forma di contenuto presente nel sito o per l'accesso o l'uso del materiale contenuto in altri siti.
Inoltre Il contenuto scritto di questo sito non può essere riprodotto, trascritto, memorizzato in un sistema di recupero dei dati, tradotto in modo manuale o automatico, ritrasmesso in qualunque forma o mezzo, rivenduto o ridistribuito salvo previa autorizzazione da parte di Luigi Favino.
Informativa Privacy
di Luigi Favino
Nella presente sezione viene fornita l'informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito di LUIGIFAVINO.it, ha valore anche ai fini dell' art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali. LUIGIFAVINO.it rende noto che il trattamento dei dati personali sarà conforme a quanto previsto dalla normativa vigente. L’ informativa è resa in ordine al trattamento dei dati personali conseguente alla consultazione del sito www.monnoroma.it e non anche per altri siti web che possono essere consultati dall’utente tramite link esterni pubblicati sul sito medesimo:
Google https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it
Firefox https://www.mozilla.org/it/privacy
Chrome https://www.google.it/chrome/privacy
Opera https://www.opera.com/it/privacy
Safari Apple https://www.apple.com/legal/privacy/it
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il sig. Luigi Favino. Per ogni chiarimento o esercizio dei diritti dell’utente potrà essere contatto al seguente indirizzo email:
luigifavino@luigifavino.it.
Per ogni chiarimento o esercizio dei diritti dell’utente il responsabile della protezione dei dati personali potrà essere contattato al seguente indirizzo email:
luigifavino@luigifavino.it.
- Finalità del trattamento e base giuridica: LUIGIFAVINO.it tratta i dati personali in relazione ai servizi offerti attraverso il proprio sito www.monnoroma.it esclusivamente per le finalità di interesse pubblico secondo la legislazione Italiana ed Europea. Nell’ambito delle predette finalità, il trattamento riguarda anche i dati personali necessari ad abilitare l’utente, che lo richiede, alla fruizione dei servizi erogati nel sito di LUIGIFAVINO.it. Si fa presente che il servizio newsletter va appositamente richiesto, prestando specifico consenso al momento dell’iscrizione, il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento, con conseguente disattivazione del servizio.
- Dati di navigazione: i sistemi informatici preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, non vengono raccolti allo scopo di associarli a soggetti identificati ma vengono trattati allo scopo di: ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.). Tuttavia, per la loro natura, potrebbero consentire di identificare gli utenti attraverso elaborazioni ed associazioni di dati detenuti da terzi, soprattutto ove sia necessario accertare le responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
- Dati forniti volontariamente dall’utente: l’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati nei differenti canali di accesso al sito e la compilazione dei form comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste degli utenti.
- Modalità di trattamento e conservazione dei dati: in relazione alle finalità descritte, i dati verranno trattati tramite strumenti cartacei, informatici e telematici dal titolare del sito nel rispetto della normativa sopra richiamata e comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza. I dati personali conferiti potranno essere oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità connesse al raggiungimento degli scopi per i quali vengono richiesti. Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, previo consenso libero ed esplicito dell’utente, i dati personali dello stesso saranno conservati per un periodo di 12 mesi necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
- Diritti dell’utente: gli utenti hanno diritto di chiedere a LUIGIFAVINO.it rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento che li riguarda, il diritto di chiedere l’aggiornamento dei dati, se incompleti o erronei, di opporsi al loro trattamento. L’istanza è presentata contattando il Titolare della Protezione dei Dati.
Il presente documento, pubblicato all'indirizzo: www.luigifavino.it costituisce la privacy policy di questo sito. Esso può essere soggetto a modifiche o aggiornamenti. Qualora si tratti di modifiche ed aggiornamenti rilevanti questi saranno segnalati con apposite notifiche agli utenti.
Il documento è stato aggiornato in data 23 dicembre 2018 per essere conforme alle disposizioni normative in materia, ed in particolare in conformità al Regolamento UE 2016/679.
Informativa per l'utilizzo dei Cookie
di Luigi Favino
Nella presente sezione viene fornita l'informativa per l'utilizzo dei cookie. I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, memorizzazione delle preferenze, ecc. L’accesso ad una o più pagine del sito LUIGIFAVINO.it può generare i seguenti tipi di cookies:
- Cookie tecnici: LUIGIFAVINO.it utilizza cookie analitici, assimilati ai cookie tecnici in quanto utilizzati a soli fini statistici per raccogliere informazioni degli utenti e su come questi visitano il sito: tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito; nome dell’Internet Service Provider (ISP); data e orario di visita; pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita; il numero di click. I dati ricavabili da questi cookie (compresi gli indirizzi IP) sono, infatti, trattati da LUIGIFAVINO.it, in qualità di gestore del sito, esclusivamente per finalità statistiche e per l’elaborazione di report sull’utilizzo del sito stesso. Vengono inoltre utilizzati cookie di sessione per garantire un’efficace navigazione e fruizione del sito web. L’uso di questi cookie non consente l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
- Cookie di profilazione: LUIGIFAVINO.it non utilizza cookie di profilazione proprietari, cioè cookie volti a creare profili relativi all’utente al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate nell’ambito della navigazione sul sito di www.luigifavino.it.
- Cookie di terze parti: per l’utilizzo dei social network e di altre applicazioni multimediali possono essere installati sul terminale degli utenti tramite il sito di LUIGIFAVINO.it cookie di terze parti, sulle quali gravano gli obblighi di informativa e consenso prescritti dal Garante per la protezione dei dati personali. I cookie installati sul sito LUIGIFAVINO.it per i servizi garantiti da terze parti sono riconducibili ai social sotto indicati a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, ai quali si rimanda per la consultazione delle relative policy e informative:
Facebook https://it-it.facebook.com/policy.php
Twitter https://twitter.com/it/privacy
YouTube https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=it
Google+ https://policies.google.com/privacy?hl=it
Instagram https://help.instagram.com/519522125107875
LUIGIFAVINO.it, quale intermediario tecnico tra le terze parti e gli utenti, fornisce, la necessaria informativa al momento dell’accesso ai suddetti social e applicazioni multimediali, mediante un messaggio contenente una prima informativa “breve”, la richiesta di consenso all’uso dei cookie, un link per accedere ad un’informativa più estesa e alla possibilità di negare il consenso all’istallazione dei cookie. Si precisa che l’eventuale prosecuzione della navigazione ignorando il banner informativo comporta l’implicito consenso all’uso dei cookie in argomento.
- Disabilitare i cookie sul proprio dispositivo: la maggior parte dei browser accetta i cookies automaticamente, ma è possibile rifiutarli. Se non si desidera ricevere o memorizzare i cookie, si possono modificare le impostazioni di sicurezza del browser utilizzato (ad es.: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, ecc…). Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. Indicazioni circa le modalità di gestione dei cookie possono essere acquisite consultando i siti ufficiali dei browser.
ALLA PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA LE BELLE AUTO DELL’ ASI AUTOSHOW
di Luigi Favino
L’ultima settimana di settembre 2018 ha visto bellissime auto storiche e d’epoca rivivere nei viali che costeggiano le Terme di Caracalla il fulgido passato delle “vecchie signore”.
La Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca si è conclusa a Roma domenica 23 settembre con un Convegno al Senato e con centinaia di vetture giunte da tutta la Penisola a mostrare ancora una volta il genio dello stile italiano al grosso pubblico della Città Eterna.
Ferrari e Maserati a decine erano parcheggiate al sole di Roma con le migliori auto tedesche e francesi lungo i viali laterali che scorrono dal piazzale della FAO rispettivamente dalle chiese di San Nereo ed Achilleo a San Sisto papa, la dove finisce la valle di Egeria, che tra il Celio e il Montedoro scende fino a Porta Capena e l’ Appia nella direzione di Capua.
Il raduno di tutte queste belle auto è cominciato proprio là dove la leggenda degli antichi vuole che in questa valle il Re Numa colloquiasse con Egeria, tra il tempio delle Camene e la Villa Mattei, che scendeva dal Celio.
Su tutte le auto dominavano le Terme Antoniane di Caracalla ultimate da Eliogabalo, che Olimpiodoro descrive decorate da numerosi portici marmorei e con colonne di granito, che solo l’ampio quadrilatero della pianta, nella parte della pinacoteca ne aveva ben 8 enormi, delle quali si scorgono ancora le basi. L’ultima di queste colonne fu fatta trasportare da Cosimo dè Medici nel 1500 a Firenze posta davanti al Ponte della S. Trinità sormontata da una statua della Giustizia.
Un panorama così, con tante belle auto d’epoca ha creato uno scenario unico: la passeggiata archeologica di Roma con i suoi pini centenari, i cipressi, con le querce e i platani ha dato il suo benvenuto a queste quasi centenarie opere dell’ingegno umano, in un tranquillo weekend di settembre, accanto a sontuosi edifici romani, che nella storia millenaria avevano addirittura gradinate per gli spettatori come quelle del Circo Massimo.




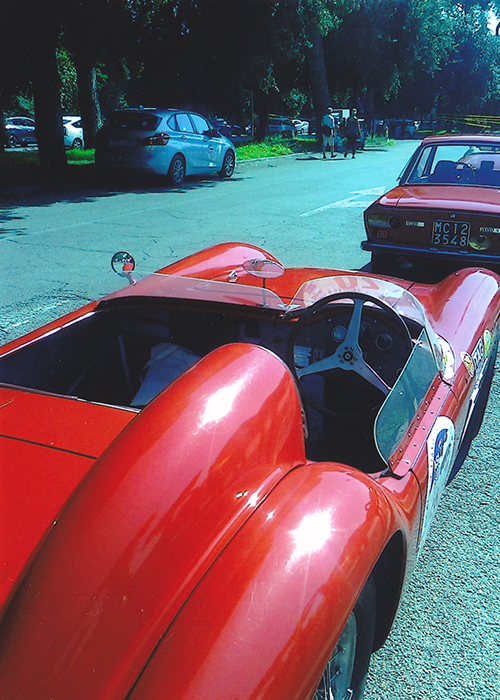


LA GAIA SOCIETA’ DEL BELLI TRA TEATRI E SALOTTI DELLA CAPITALE
di Luigi Favino
Nella Roma di metà Ottocento ferveva una vita molto intensa fatta di eventi musicali, teatrali ed artistici. A questi, il popolo descritto dal Belli nei Sonetti, partecipava attivamente affollando soprattutto spettacoli di ballerine e il nuovo genere "composito" di quegli anni: il melodramma, un po' tra il "musical" americano dei nostri anni Venti con balli, prosa, romanze o assoli, ma tuttavia simile all'operetta". La quale senza essere la figlia minore dell'opera lirica, pur tuttavia ne costituiva un superamento per l' orecchiabilità dei motivetti in generale che potevano definirsi - come sottolineava Gioaechino Belli - "semiseri".
Il Poeta, del resto non mancava quasi mai alle Prime di questi spettacoli per cercare di memorizzare leggende, "gossip", parole ed espressioni - se si può dire -dell' “argot" franco-romanesco con cui il poeta riusciva a colorare i suoi sonetti con una tavolozza linguistica che non dimenticava la fraseologia giudaica.
Ogni occasione era buona per il "banco di prova" del testo: come un ricevimento, un pranzo o le "conversazioni" tipiche di certi salotti, dove il Belli leggeva la sua Poesia, suscitando stupore e riscuotendo complimenti per quell'improvvisata "soiré”, dove altri artisti suonavano o si esibivano in pezzi tratti da spartiti musicali, con il bel canto. I salotti romani erano l'eco dei media di allora, ma anche il laboratorio in attesa del varo ufficiale di un'opera in Teatri come potevano essere il Valle, l'Argentina o l'Aliberti. Ma non solo i salotti, perché anche nel popolo minuto, in quella Roma di metà Ottocento, si manifestava il desiderio o la tendenza alla pubblicità e al lancio di qualche "genio" musicale, come il Belli ha voluto esprimersi nel Sonetto La Musicarola del 1847, dove la giovane Albina è nominata assieme alla celebre Malibran.
Brava! Ma ssai che canti bene, Arbina?
Sentite lì ssi che belli trilletti!
E pperché co sta voce nun te metti
Sur teatro de Valle o d'Argentina?
Te dich' io che li banchi e liparchetti
Li faressi affollà da la matina:
Che ciai 'na grazzia a ffà la canterina
Quanta n'ha l'orzo a lavorà merletti.
Hai cantata quell'aria, Arbina mia,
che ssi c'era madama Melibbranni
Se sbajava la porta a scappà via.
Manni dar corpo una vocetta, manni,
Che, s'opri bocca da Piazza Giudìa,
S'attureno l'orecchie a Ssan Giovanni.
Questo sonetto è stato l'ultimo scritto dal Belli quando aveva già maturato l’idea di non pubblicarli affatto; probabilmente in un momento critico della propria esistenza, circa quindici anni prima della sua dipartita. Ma tornando alla gaia società romana dei salotti e dei ricevimenti, dei pranzi e delle occasioni per coltivare, anche allora, le cosiddette "public relations" il serioso Belli, che fu uno dei fondatori della rinomata Accademia Tiberina, non disdegnava queste frequentazioni e anzi in un sonetto, Er nobile de fresca data, è stato ancora più esplicito, ma pur sempre elegante chiamando i volgari "sordi" col "priffete".
Import'assai si ha ffatto er friggitore
E si è stato a la pietra in pescaria!
Er priffete è la vera signoria
Chi ha quadrini quaggiù sempre è un signore,
Dice: Ma a casa sua, sia che se sia,
Non ce capita un cane e ce se more
De pizzichi? E che fà? Sto disonore
J'intraviè pè' la su' spilorceria.
Lui cominci un po' a spenne e a dà da pranzo,
E troverà l'appartamento pieno;
E si vo' amichi, n' averà d'avanzo.
Minestra, dieci piatti, caciò e frutti,
Eppoi vedi la folla! Ar meno, ar meno
Li cardinali ciannerlano tutti.
Quanto al melodramma e agli spettacoli musicali, abbiamo detto come il Belli fosse un frequentatore assiduo di teatri come il Valle, l’Argentina ed altri, dove le novità musicali erano all’ordine del giorno e dove altrettanto gl stessi fossero frequentati da un vasto pubblico di intenditori. Ci viene in mente, a questo proposito, quel sonetto intitolato La Cerriti, in cui è protagonista una celebre ballerina che da trent’anni faceva “'tournée” anche all’estero; che però a Roma nell’autunno del 1843 venendo acclamata dentro e fuori dal Teatro Aliberti con corone di fiori e pietre preziose, fosse accompagnata fin sotto casa sua a Piazza di Spagna da un folto corteo di folla. Ne nacque una confusione e un vero bailamme in tutte le vie adiacenti, sedato soltanto dopo l’intervento dei carabinieri con raffiche di spari a salve, che disperselo l’assembramento che era costituito da “fans” e detrattori venuti alle mani tra loro. Non condividendo affatto quella sorta di ''happening” Belli scrisse questo sonetto:
Cert’ è che sta Ceriti, sor Camillo,
Tra ffiori e cceste e scartafacci a botte
Da du’ora inzinent’a mezza notte.
Sartò in zur gusto de ‘na purcia o un grillo.
Ma c’a ‘gni zompo meritassi un strillo
Da sti guitti fijacci de mignotte,
Saria facenna de mannà a ffà fotte
Loro e chiunque s’azzardassi a dillo.
Eh da qui avanti appena piscia un cane,
Che ssiino buggiarati in zempiterno,
Se sfogheranno a ffuria de campane.
A mmé occhi me fa spece è der Governo.
Che invece, cazzo, de fa cresce er pane,
Averia da impedì ttutto st’inferno.
Dal sonetto appare chiaramente che gli spettatori non si contentassero più di assistere passivamente alle esibizioni degli artisti, ma che invece sempre più spesso prendevano parte allo spettacolo con l’intenzione dì proseguire la partecipazione a sipario calato, tentando di invadere la sfera privata della “star” del tempo. Tuttavia, la folla che si riunisce in soprannumero, costituiva allora pur sempre un pericolo per l’igiene e l’epidemie tanto che, nell’estate 1835 furono prese delle misure contro il colera, che era arrivato anche nella Capitale. In questo caso il Belli, che era tuttavia uomo d’ordine, si schierò dalla parte di coloro che non volevano la chiusura dei teatri e dei pubblici trattenimenti scrivendo un sonetto contro quella normativa che avrebbe impedito alla gente di divertirsi come voleva e agli impresari di morire di fame (come a Giovanni Patemi, uno dei più noti).
Innibì le commedie?! E in che maggnera?
V’immagginate sta leggiaccia infame?
Tanto bene, sor faccia de tigame,
S’opre er teatro e sta notizzia è vera.
Un povero garzon del faleggname
Che ciabbusca du’ pavoli pe ssera,
Pe nun morì domani de collèra
S’avrebbe oggi da morì de fame?
Nun ve pòzzo negà c’ar zor Paterno
Je fa er culo un tantin de lippe-lappe,
io però dico che ce vince un terno.
Perché, famo er colléra che vienisse
Co ttutta la pavura in ne la chiappe
Chi resta vivo vorà divertisse.
Il sonetto fa parte di una piccola raccolta di altri 34 intitolata dal Belli “Er collera moribbus”, “Conversazione a l’osteria de la Genzola” a Trastevere.
“Cholera morbus” era la denominazione ufficiale dell’epidemia che dalla Francia era venuta in Italia e anche nello Stato Vaticano; ma Belli giocando tra il latino e la deformazione popolare, adombra la collera divina di pura estrazione ecclesiastica, per il degrado ambientale di Roma che favoriva la propagazione del bacillo ed intitola la raccolta, letteralmente “indisposta e ariccontata co trentaquattro sonetti e tutti de grinza”!
Se al pubblico romano era consentito soltanto di assistere allo spettacolo senza incontri personali né manifestazioni collettive di entusiasmo per gli artisti, per i letterati come il Belli erano aperti tutti i salotti nella Roma capitale dello Stato Pontificio, per incontrare gli artisti e i poeti che vi transitavano e per confrontarsi con la benedizione degli anfitrioni, padroni di casa.
In uno di questi salotti, quello di Iacopo Ferretti, poeta e librettista, forse il più rappresentativo in quello scorcio del primo trentennio dell’Ottocento romano, il Belli ebbe ad incontrare il compositore di Bergamo, Gaetano Donizetti, che grazie anche all’opera del Ferretti (autore dei libretti) che scriveva per lui le opere liriche, era divenuto abbastanza popolare. Spesso Donizetti era ospite dell’amico che abitava nell’omonimo Palazzo Ferretti, già Amadei, tra via delle Stimmate e via Cesarini, poi demolito pe far luogo al progetto del nuovo Corso Vittorio Emanuele. A Donizetti l’amico Belli dedicò ne 1832 il bellissimo sonetto “Er Teatro Valle” nel quale il poeta, si fa per dire, “metteva in scena” in poche sintetiche battute una delle prime opere del bergamasco, “Gli esiliati in Siberia”. Eccone il testo:
Io pe nnun perderne, Anna de Pumpara,
La Spaccata, Chiafò, Ccuccio e Lluterio,
Annassimo a la Valle in piccionara,
Che cc’è la meladramma e ’r zeme-serio.
E’ un certo Puggnatoschi, che da Zzara
Lo mannorno in esijjo in ner Zibberio:
E cc’è un’Unghera sc’è cche la pianara
La porta a ggalla drent’a un cimiterio.
Usscì er Bazzane, de Moscovia poi.
Che sse scibbò una sarva de fischietti,
E li primi a flischià ffussimo noi.
Oggni tanto però da li parchetti
Se sentiva a rripète un tibbidoi
D’apprausi ar machinista e a Ddozzinetti.
Si trattava di un “melodramma semiserio” del noto compositore, tratto da un romanzo di M.me Alme Cottin sul libretto di Iacopo Ferretti, il cui salotto era frequentato anche dal Belli. Il maestro nativo di Bergamo è identificato nel sonetto come “Dozzinetti” per la sua prolificità musicale operistica nota agli “addetti ai lavori”, ma che comunque richiamava un notevole seguito di “fans” e appassionati della musica lirica. Gaetano Donizzetti infatti, venendo già da anni ogni tanto a Roma, vi conobbe e sposò nel 1828 nella chiesa di S. Maria in Via, la bella Virginia Vasselli.
Il 25 maggio del 1998 nella ricorrenza del secondo Centenario della nascita e nel 150/o della morte di Gaetano Donizetti, nel quadro delle Celebrazioni ufficiali tenutesi a Bergamo e in altre Capitali Europee, è stato ricordato il compositore al Teatro di Roma unitamente all’amico Gioacchino con uno spettacolo speciale, nel quale sono state eseguite musiche inedite di Donizetti e letti sonetti del Belli, nel corso della serata a loro dedicata.
Tra le musiche inedite di Donizetti, quelle ritrovate di recente nell’Archivio di Casa del Palazzo Ferretti, vi era anche un album di ben 13 composizioni autografe ed inedite del grande musicista, tra cui la romanza da camera che qui riportiamo, presa dal libretto della serata al teatro Argentina del 25 marzo 1998. (di cui abbiamo già accennato) in cui fu eseguita dal soprano Maria Vulpi e dal pianista Martino Faggioni dal titolo “Nel primo fior degl’anni”, il cui testo di seguito riportiamo:
Nel primo fior degl’anni
penar, languir dovrò.
Nei miei spietati affanni
narrar spiegar potrò.
Che strano cimento
che strazio che pena.
mostrar nel tormento
la fronte serena
sugl’occhi, sul viso
di pianto bagnato
costringere il riso
mentire il piacer,
Oh barbaro stato
oh crudo dover.
Secondo le tradizioni dei salotti romani, gli artisti che erano stati ospiti di questi ritrovi, solevano lasciare per riconoscenza un qualche ricordo della loro visita in quel salotto, trascrivendo su un Album apposito una romanza o una poesia o un brano di prosa tutti dedicati alla padrona di casa, che nella specie era la signora Teresa Terziani Ferretti che aveva tre bellissime figlie, una delle quali, Cristina, andò sposa a Ciro, il figlio di Gioacchino Belli.
Importante fu la frequentazione dei salotti romani da parte del Belli, perché è proprio grazie a questi se oggi sono pervenute a noi la raccolta di migliaia di queste uniche poesie che, ascoltate da letterati ed artisti soprattutto stranieri del tempo, ne parlarono in qualche loro scritto diffondendo la fama del poeta che non solo non osava pubblicarle, ma addirittura aveva dato ordine di distruggerli.
Uno dei primi intellettuali stranieri che conobbe il genio del Belli fu il russo Nicoloi Gogol che scrisse di aver ascoltato qualche sonetto del poeta nel salotto della principessa polacca Zenaide Wolkowsky nel 1838, probabilmente nella bellissima villa a San Giovanni, tutt’ora sede dell’ambasciata inglese a Roma. Anche grazie a lui non sono andati perduti questi capolavori!
NOTE: L'ARTICOLO E' STATO PUBBLICATO SOLO IN ITALIA, SI VALUTANO RICHIESTE DI PUBBLICAZIONE SU STAMPA ESTERA.
Impressioni di poeti e scrittori "Turisti" nella Roma del Belli
di Luigi Favino
“La cupola I'ho veduta io con la mia corta vista a cinque miglia di distanza mentre io sempre ero in viaggio; e I'ho veduta distintamente con la sua palla e colla sua croce come voi vedete di costà gli Appennini". Così scriveva Giacomo Leopardi alla sorella Paolina il 3 dicembre 1822, quando venuto a Roma da Recanati aveva intravisto la Capitale percorrendo la via Flaminia; quasi una sorpresa questa visione ma assieme a tante altre impressioni non tutte positive, tra cui quella che Roma fosse una città disordinata e sporca nella periferia, e disabitata al centro. In effetti Leopardi aveva ragione perché la periferia campestre deserta che attraversava la via consolare, quella stessa che Goethe aveva percorso venendo a Roma, aveva suggerito al poeta tedesco identiche sensazioni consegnate ai suoi Reisenbilder (taccuini di viaggio), al limite della delusione. Similmente in tempi diversi, altri viaggiatori illustri scrissero di essere stati preoccupati per la mancanza di sicurezza lungo il viaggio per le strade che portavano a Roma. Tra i nomi più noti va ricordato il Marchese Alphonse Donatien De Sade, che nel suo Voyage d'Italie, arrivato a Ronciglione sulla Cassia del tempo, scriveva:
“De Ronciglione je fus coucher à une mouvaise poste
nommée Baccano... voulant avoir de jour le coup d'oeil
de I'entrée de cette capital du monde... A plus de six
milles avant d'arriver à Rome, on voit la coupole de
Saint-Pierre qui s'élève au-dessus de tout... Le sang est
vilain dans ces environs-là et les paysannes sont grosses
et fort épaisses. On voit de cette méme distance
quelques anciens monuments repandus dans la plaine
et le long du chemin”.
Bruno Cagli, uno dei più sensibili commentatori di Belli, per tutte le edizioni dei Sonetti del Belli ha scritto proprio su questo argomento, che i viaggiatori che provenivano dal Nord sulle due consolari notavano tutti "un deserto desolato" ed erano come “soggiogati da un silenzio di morte, quasi un funebre preludio che precedeva l'attesa visione della Capitale del mondo”. Lo stesso Belli, che conosceva la zona e tutti i luoghi intorno a Roma, nel sonetto Er deserto (numero 1756 del 21 marzo 1836) spiega al lettore il perché di tutto questo in modo piuttosto crudo:
Dio me ne guardi, Cristo e la Madonna
D'annà ppiù ppe giuncata a sto precojo.
Prima... che pposso dì?...prima me vojo
Fà castrà da un norcino a la Ritonna.
Fà dieci míja e nun vedè nafronna!
Imbatte ammalappena in quarche scojo!
Dapertutto un silenzio come un ojo,
Che ssí strilli nun c'è chi tt'arisponna!
Dove te vorti una campaggna rasa
Come ce sii passata la pianozza,
Senza manco I'impronta d'una casa!
L'unica cosa c'ho ttrovato
In tutto er viaggio, è stata una barrozza
Cor barrozzaro giù morto ammazzato.
E nel sonetto numero 184 (dell'11 ottobre I83l) Spenni poco e stai bene il Poeta allarga il discorso sulla sicurezza anche agli abitanti dei piccoli centri, come aveva scritto De Sade, per chi soltanto li visitava passandoci per arrivare a Roma, c'era questa "via crucis" che generava sentimenti che andavano dalla delusione, alla rabbia e al timore.
Càpita a Monte-Rosi, o a li confini,
La Storta vojo dì, Nepi e Baccano;
E nun te dubbità: sei 'n bone mano,
Ch'è tutta 'na Fajòla d'assassini.
Te coceno du'polli bufolini:
Te cacceno un vinetto de Pisciano
Battezzato coll'acqua de pantano:
Te danno un letto morbido de spini.
Te metteno la notte in compaggnia
Purce, zampane, cimice e ppidocchi,
Che tte fanno cantà Viva Maria!
E quanno er zonno t'ha sserrato I'occhi
Te viengheno a chiamà per annà via.
E ttutto questo pe ppochi baiocchi.
Meno severi furono Berlioz e Stendhal, sensibili al fascino della Romanita, anche se il cuore del secondo battesse per Milano, citta già più attiva ed organizzata di Roma, che tuttavia sempre godeva di quell'aureola che Winkelmann le aveva posto sul capo e che esercitava ancora, all'epoca della Restaurazione, sugli spiriti liberi e sugli intellettuali di mezza Europa un richiamo tanto forte da indurli a viaggi avventurosi pur di vedere di persona gli archi e i monumenti ancora intatti della Roma imperiale repubblicana, superficialmente definiti a torto come rovine.
Lo stesso Leopardi che aveva avuto, come visto, un' impressione negativa all' entrare in città, purtuttavia ne aveva un alto senso di rispetto per quanto ancora la stessa possedeva di antico, originale e conservato. Ce lo dice in una lettera al fratello Carlo a Recanati, che ha per oggetto la visita alla tomba del Tasso sul Gianicolo (del 16 dicembre 1822) nella quale Leopardi sottolinea il contrasto in lui suscitato tra la grandezza del Tasso e l'umiltà della sua sepoltura:
“Tu non puoi avere idea di quello che prova un occhio avvezzo all'infinita magnificenza e vastità dei monumenti romani, paragonandoli alla piccolezza e nudità di questo sepolcro”. Fatto questo che gli procurò un senso di indignazione come meglio spiega di seguito: “Al vedere il cenere del Tasso coperto ed indicato non da altro che da una pietra larga e lunga circa un palmo e mezzo, posto in un cantoncino di una chiesuccia. Anche la strada che conduce a quel luogo è tutta costeggiata da case destinate alle manifatture e risuona dello strepito dei telai”.
Ai tempi di Belli e Leopardi il Gianicolo non era come è oggi, un parco architettonicamente studiato e aperto al pubblico; e non vi sono più intorno al sepolcro le case di cui parla il Leopardi, perché si esauriscono nella salita di S. Onofrio, in parte sostituite dall'Ospedale del Bambin Gesù che è situato nel lato opposto della strada che conduce al Gianicolo. Per cui la tomba del Tasso gode di una posizione privilegiata in uno spazio alberato, fatto di verde e nella quiete più assoluta, salvo quando vi si fanno gli spettacoli teatrali le sere d’estate proprio nel sito stesso denominato "quercia del Tasso". Il Poeta è pertanto ricordato e nominato oggi più di quanto non fosse ai tempi del Poeta di "Silvia". Malgrado la famiglia del Belli provenisse dalla città natale di Leopardi, i due non ebbero mai modo d'incontrarsi, né a Roma, dove quest'ultimo alloggiò presso la famiglia degli zii antici, né a Recanati dove pure il Belli in qualche viaggio nelle Marche era più volte ritornato.
Entrambi tuttavia avevano nel poeta Vincenzo Monti un punto di riferimento. Il Belli infatti aveva scritto un Canzoniere in lingua italiana e prima di iniziare a scrivere i Sonetti, intorno al 1829, frequentava i poeti e i letterati dell'Accademia Tiberina, di cui era "magna pars". E il Monti, d'altra parte, aveva interessi a Roma, dove era conosciuto ed apprezzato al punto di avere ricevuto I'incarico dal Papa Pio VI Braschi di celebrare una sua iniziativa: l’impresa della bonifica delle paludi pontine con un poema, La Feroniade. L'impresa però non fu portata a termine ed anche il poema rimase incompiuto. Tutto questo bastò ad accrescere la fama del Poeta anche a Roma ed anche quella del Papa come mecenate che diede seguito pubblicamente ad un'altra iniziativa: la costruzione a Piazza Navona dello splendido Palazzo Braschi per il nipote Luigi, un'opera di grande sfarzo e molto chiacchierata al tempo del Belli, tanto che questi non si lasciò sfuggire I'occasione di dedicargli un sonetto: Li Miracoli (numero 1691 del 29 ottobre 1835):
Li miracoli, caro sor Donato,
L'hanno sempre da fà li Santi novi;
Perchè a questi pò èsse cheje giovi,
E li vecchi hanno bell'e assicurato.
Chi vò adesso míracoli li trovi
In quarche Venerabbile o Beato;
Ma a cercalli in un Zanto staggionato
E' inutile inzinenta che ce provi.
Nun vedete I'Apostoli, sor coso,
Da quanto tempo hanno finito er patto
E sse sò messi in stato de riposo?
Benché ssan Pietro nun abbotta fiaschi;
E I'urtimo miracolo I'ha ffatto
A ttempi nostri in ner Palazzo Braschi.
La satira non impediva al Poeta di avere un ideale politico e religioso allo stesso tempo, poiché in una città come Roma la politica non era mai disgiunta dalla religione; questa era pura esteriorità, mentre il richiamo al Vangelo il vero ideale. In più di un sonetto, infatti, si ritrova questo refrain, come in quello del Er bon governo (numero 1793 del25 settembre 1836), in cui più che la fede e la speranza il Buon Governo deve perseguire un ideale di carità, per aiutare sempre i poverelli.
Un bon governo, fiji, nun è quello
Che v'abbotta I'orecchie in zempiterno
De viscere pietose e cor paterno:
Puro er lupo s'ammaschera da aggnello.
Nun ve fate confonne: uri bon governo
Se sta zitto e ssoccorre er poverello.
Er restante, fijoli, è ttutt'orpello
Pe accecà I'occhi e comparì a I'isterno.
Er vino a bommercato, er pane grosso,
Li pesi giusti, le piggione basse,
Bona la robba che portamo addosso...
Ecco cos'ha da fà un governo bono;
E no piaggneve er morto, e poi maggnasse
Quant'avete, e lassavve in abbandono.
Un poeta e letterato romano come il Belli sarebbe rimasto pressoché sconosciuto, se nel 1 829 non avesse scritto il primo sonetto in romanesco, e poi non avesse proseguito a scrivere quella composita raccolta che oggi costituisce I'unica sua grande opera. Infatti solo con questa conquistò, come il Porta a Milano, uno dei primi posti nella letteratura dell'800 della penisola. Aiutato in questo dalle circostanze storiche che avevano ridotto la Repubblica Romana all'indomani del periodo napoleonico ad "un deserto culturale, morale e civile" (v. Cagli, op. cit., p. 15), il deserto del cosiddetto periodo della Restaurazione, che abrogò tutte le leggi napoleoniche dell'occupazione di Roma. Ma questa tuttavia non fu da meno perché soffocò qualsiasi ventata di rinnovamento anche nell'arte e nell'urbanistica, al punto da voler revocare quel poco di buono che era stato fatto nell'arte, ad esempio con il progetto della costruzione del Pincio da parte del Valadier, per il solo fatto che era stata iniziata per volere di Napoleone. Tuttavia per fortuna l'opera venne ultimata melius re perpensa. Sul periodo francese un sonetto del Belli sintetizza icasticamente la Roma del tempo: Er tempo dei francesi (numero 1726 dell'8 febbraio 1836):
Un po' più che durava Napujone
Co quell'antri monzù scommunicati,
Roma veniva a diventà Ffrascati,
Schifanoia, o Castel-Formicolone.
E ssedute, e demanio, e coscrizzione,
Giuramenti a li preti e a I'avocati,
Carc'in culo a le moniche e a li frati,
Case buttate giù, chiese a ppigione...
Li monziggnori in Corzica e a Ssan Leo:
Li vescovi oggni sempre sur pitale
Pe la paura de cantà er Tadèo:
Er Papa a Ffontebbrò: Montecavallo
Vòto: San Pietro vòto; e un cardinale
Nun lo trovàvio ppiù manco a ppagallo.
Il citato deserto della Restaurazione non sfuggì neppure a Leopardi, che in quel breve periodo di permanenza a Roma ne percepì la presenza che condizionava la vita grama degli abitanti, scrivendone anche alla sorella Paolina in una delle lettere. Dello stesso avviso furono diversi altri scrittori tra cui in particolare I'Alfiere che "fotografò" in un incisivo verso lo "Stato romano" di quel periodo: “vasta e insalubre region che Stato osi nomarti”. Sullo stesso tono lo Stendhal che sinteticamente lo definì "Tartarie chinoise" in una sua lettera al Conte Roederer il 19 luglio 1831 descrivendo le condizioni degradate in cui si viveva a Roma ma anche il Belli era sulla stessa Lunghezza d'onda perché in più di un sonetto dipinse la situazione nella città scrivendo cose fondate e vere, non meno degli scrittori citati, perché la verità è un dovere riconoscerla e raccontarla proprio come meglio ha precisato nell'omonimo sonetto La Verità (numero 858 dell'11 febbraio 1833):
“La Verità è ccom'è la cacarella.
che cquanno te viè ll'impito e tte scappa
hai tempo, fijja, de serrà la chiappa
e stòrcete e ttremà ppe rcitenella.
E accusì, ssi la bbocca nun z'attappa,
la Santa Verità sbrodolarella
t'essce fora da sé dda le bbudella,
fussi tu ppuro un frate de la Trappa.
Perchè ss'ha da stà zzitti, o ddì una miffa
oggni cuarvorta sò le cose vere?
No: a ttemp'e lloco d'aggriffà ss'aggriffa.
Le bbocche nostre Iddio le vò ssincere,
e ll'ommini je metteno l'abbiffa?
No: ssempre verità: ssempre er dovere”.
Lo scenario nel quale lo Stato Pontificio governava Roma era quello di un'accentuata decadenza, della corruzione della classe dirigente e della povertà generale delle famiglie e soprattutto dell'alta mortalità che impediva l'aumento degli abitanti facendo di Roma una città quasi disabitata. Molti sonetti del Belli affrontano il problema della morte e dei riti che all'epoca erano seguiti a seconda
del ceto sociale del morto, da parte delle confraternite e delle autorità demandate alla sepoltura delle persone. In particolare, a novembre nella settimana dei defunti venivano organizzate mostre di fiori realizzate con le ossa dei morti, fiori anche probabilmente usati nelle sacre rappresentazioni in onore dei defunti. Nel suo volume Rome, Naples et Florence Stendhal, che per un periodo aveva albergato a Roma, raccontava di essere rimasto colpito dalla morte di una nobildonna romana, la principessa Boncompagni, letteralmente così scrive: “Il mio stupore misto ad orrore quando trovai nella chiesa degli Apostoli questa giovane e stupenda donna di diciannove anni col belletto, stesa sul catafalco e circondata da sette o otto preti mezzo addormentati, verso mezzanotte” (omissis) “La morte che sul campo di battaglia non mi era sembrata altro che una porta aperta o chiusa, e che finché non è chiusa è aperta, mi perseguita con una immagine orrenda da quando ho visto quella figura celestiale col suo belletto. Che dire dell'orrore del giorno dopo quando al calar della notte la vidi passar per le vie, stesa su di una lettiga e sempre con il capo scopetto?”.
La grandezza di Stendhal sicuramente riesce a rendere più drammatica tutta la scena raccontata da par suo, in due distinti momenti. Ma Belli ci dice che quelle scene si ripetevano a Roma, giorno e notte, come raccontato nel sonetto che fa della cerimonia della morte una fotocopia della vita di tutti i giorni, con le stesse situazioni, classi ed ingiustizie, quello de Li morti de Roma (n.787
del 23 gennaio 1833):
Quelli mortí che ssò dde mezza tacca
Fra ttanta ggente che sse va a ffà fotte,
Vanno de ggiorno, cantanno a la stracca,
Verzo la bbúscia che sse I'ha dda iggnotte.
Cuell'antri, in cammio, c'hanno la patacca
De Siggnori e dde fijji de miggnotte,
Sò ppiú cciovili, e ttiengheno la cacca
De fuggì er Zole, e dde viaggià dde notte.
Cc'è ppoi 'na terza sorte de figura,
'N'antra spesce de morti, che ccammina
Senza moccoli e ccassa in zepportura.
Cuesti semo noantri Crementina,
Che ccottivati a ppesce de frittura,
Ce bbutteno a la mucchia de matina.[1]
[1] Per il testo dei sonetti, V. G.G. Belli, Tutti i sonetti romaneschi, a cura di Bruno Cagli, Roma, 1965, Avanzini e Torraca Editori. Per le notizie biografice ricordiamo gli scritti di insigni Romanisti: Mario Adriano Bernoni e gli Avvocati del Foro di Roma Augusto Addamiano e, soprattutto, Salvatore Rebecchini.
NOTE: L'ARTICOLO E' STATO PUBBLICATO SOLO IN ITALIA, SI VALUTANO RICHIESTE DI PUBBLICAZIONE SU STAMPA ESTERA.